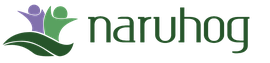Vita e costumi nel Medioevo. Prefazione Ultimi suggerimenti dalla sezione “Storia”.
Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa
Università statale di tecnologia e design di San Pietroburgo
Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali
Abstract sugli studi culturali:
“Vita e costumi del Medioevo”
San Pietroburgo
2003.
Contenuto:
1.Introduzione………………………3
2. Luminosità e intensità della vita……………..…………….4
3. Cavalleria……………………………..7
4. Il significato della cattedrale in una città medievale……………10
5. Abitante della città e tempo……………….. 14
6. La criminalità del Medioevo……………………………… …..16
7. Il ruolo della Chiesa………………………..17
7.1 Il ruolo della Chiesa nell'educazione……………………………… ….18
8. Conclusione..................................................................19
Appendice…………………...20
Elenco dei riferimenti…………………….. 21
1. Introduzione
. Volevo dare uno sguardo più da vicino alla vita in quei tempi. Come vivevano le persone? Qual era la loro moralità? Da cosa sei stato guidato nella vita? Quali preoccupazioni quotidiane occupavano le loro menti? Quanto contrastano gli interessi delle persone di oggi e di quelli di allora? Proprio come adesso c'erano le grandi città e le piazze, ma da allora molto è cambiato: se prima in piazza si sentiva
lo scricchiolio delle ruote, il clangore degli zoccoli, il battito degli zoccoli di legno, le grida dei venditori ambulanti, il ruggito e il tintinnio delle officine artigianali, ma ora questo è stato sostituito dal ritmo frenetico delle strade cittadine e degli stabilimenti industriali. Come sono cambiate le persone?
Ero interessato a scoprire quale ruolo avesse la cattedrale. E perché così tanto tempo è stato dedicato alla costruzione della cattedrale. Che significato ha dato la cattedrale alla vita pubblica?
2. Luminosità e intensità della vita
Quando il mondo era cinque secoli più giovane, tutti gli eventi della vita assumevano forme molto più nettamente definite rispetto ai nostri tempi. La sofferenza e la gioia, la sfortuna e la buona sorte sono molto più palpabili; le esperienze umane hanno mantenuto il grado di completezza e spontaneità con cui l'anima di un bambino percepisce fino ad oggi il dolore e la gioia. Ogni azione, ogni atto seguiva un rituale sviluppato ed espressivo, elevandosi a uno stile di vita duraturo e immutabile. Eventi importanti: nascita, matrimonio, morte - grazie ai sacramenti della chiesa hanno raggiunto lo splendore del mistero. Anche le cose non così significative, come viaggi, lavoro, affari o visite amichevoli, erano accompagnate da ripetute benedizioni, cerimonie, detti e venivano fornite con determinati rituali.
Non c'era modo di aspettarsi sollievo dalle disgrazie e dalle privazioni; a quel tempo erano molto più dolorose e terribili. La malattia e la salute erano molto più diverse, l'oscurità spaventosa e il freddo intenso in inverno erano un vero male. Godevano della nobiltà e della ricchezza con maggiore avidità e più seriamente, poiché si opponevano alla povertà evidente e al rifiuto molto più duramente. Un mantello foderato di pelliccia, un fuoco caldo dal focolare, vino e uno scherzo, un letto morbido e confortevole portarono quell'enorme piacere, che in seguito, forse grazie ai romanzi inglesi, divenne invariabilmente l'incarnazione più vivida delle gioie quotidiane. Tutti gli aspetti della vita venivano mostrati con arroganza e rudezza. I lebbrosi facevano roteare i sonagli e si radunavano in cortei, i mendicanti urlavano sotto i portici, mettendo a nudo il loro squallore e le loro deformità. Condizioni e classi, gradi e professioni si distinguevano per l'abbigliamento. I nobili gentiluomini si muovevano risplendenti nello splendore delle loro armi e dei loro abiti, con timore e invidia di tutti. L'amministrazione della giustizia, la comparsa di mercanti con beni, matrimoni e funerali venivano annunciati a gran voce con grida, cortei, pianti e musica. Gli amanti indossavano i colori della loro dama, i membri della confraternita indossavano il loro emblema e i sostenitori di una persona influente indossavano distintivi e insegne corrispondenti.
Anche l'aspetto delle città e dei villaggi era dominato dalla diversità e dai contrasti. La città medievale non si fondeva, come le nostre città, in squallide periferie con case semplici e fabbriche noiose, ma agiva come un tutt'uno, circondato da mura e irto di formidabili torri. Non importa quanto alte e massicce fossero le case di pietra dei mercanti o dei nobili, gli edifici del tempio con la loro mole regnavano maestosamente sulla città.
La differenza tra estate e inverno si sentiva più nettamente che nella nostra vita, così come tra luce e oscurità, silenzio e rumore. La città moderna difficilmente conosce l'oscurità impenetrabile, il silenzio mortale, l'impatto impressionante di una sola luce o di un solo grido lontano.
A causa dei continui contrasti, della diversità delle forme di tutto ciò che toccava la mente e i sentimenti, la vita quotidiana eccitava e infiammava le passioni, che si manifestavano o in esplosioni inaspettate di cruda sfrenatezza e brutale crudeltà, o in esplosioni di reattività spirituale, nel mutevole atmosfera di cui scorreva la vita della città medievale.
Ma un suono invariabilmente soffocava il rumore vita frenetica; per quanto vario fosse, non si mescolava con nulla e sollevava tutto ciò che era superiore nella sfera dell'ordine e della chiarezza. Questo suono di campane nella vita di tutti i giorni era paragonato all'avvertimento degli spiriti buoni che, con voci familiari, annunciavano dolore e gioia, pace e ansia, convocavano il popolo e avvertivano del pericolo imminente. Erano chiamati per nome: Roland, Fat Woman, Jacqueline - e ognuno capiva il significato di questo o quello squillo. E sebbene le campane suonassero quasi incessantemente, l'attenzione al loro suono non si attenuava. Nella continuazione del famigerato duello giudiziario tra due cittadini nel 1455, che gettò sia la città che l'intera corte borgognona in uno stato di incredibile tensione, una grande campana - "una cosa terrificante da sentire", secondo Chatellain - suonò fino al la lotta era finita. Sulle chiese campanarie di Nostra Signora di Anversa è ancora appesa un'antica campana d'allarme, fusa nel 1316 e soprannominata "Orida", cioè "Orida". horrida: spaventoso. Quale incredibile emozione deve aver colto tutti quando tutte le chiese e i monasteri di Parigi hanno suonato le campane dalla mattina alla sera - e anche di notte - in occasione dell'elezione di un papa che avrebbe dovuto porre fine allo scisma, o in onore della conclusione della pace tra i Bourguignon e gli Armagnac.
Le processioni erano senza dubbio uno spettacolo profondamente commovente. Nei momenti difficili – e accadevano spesso – i cortei si sostituivano, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Quando la disastrosa faida tra le Casate d'Orleans e le Casate di Borgogna portò infine ad una guerra civile aperta, il re Carlo VI nel 1412 dispiegò l'orifiamma per opporsi, insieme a Giovanni l'Impavido, agli Armagnac, che tradirono la loro patria stringendo un'alleanza con gli inglesi; a Parigi, durante la permanenza del re in terre ostili, si decise di organizzare processioni quotidiane. Durarono dalla fine di maggio fin quasi alla fine di luglio; vi parteciparono successivi ordini, corporazioni e corporazioni; Ogni volta camminavano lungo strade diverse e ogni volta portavano reliquie diverse. In questi giorni la gente digiunava; tutti camminavano a piedi nudi: i consiglieri parlamentari e i cittadini più poveri. Molti portavano torce o candele. C'erano sempre bambini tra i partecipanti al corteo. I contadini poveri venivano a Parigi a piedi, da lontano, scalzi. La gente camminava o guardava quelli che camminavano. Ed è stato un periodo molto piovoso.
E poi c'erano gli ingressi cerimoniali di nobili brillanti, disposti con tutta l'astuzia e l'abilità di cui la fantasia era capace. E in infinita abbondanza: esecuzioni. L'eccitazione crudele e la cruda simpatia evocate dallo spettacolo del patibolo erano una parte importante del cibo spirituale del popolo. Queste sono esibizioni con insegnamento morale. Si inventano punizioni orribili per crimini terribili. A Bruxelles, un giovane piromane e assassino è incatenato a un anello posto su un palo, attorno al quale bruciano fasci di sterpaglie e paglia. Rivolgendosi al pubblico con parole toccanti, ha addolcito i loro cuori così tanto "che hanno versato tutte le lacrime per compassione e hanno dato alla sua morte un esempio come il più bello che qualcuno avesse mai visto". Mensir Mansart du Bois, un Armagnac che sarà decapitato nel 1411. a Parigi, durante il terrore borgognone, non solo concede con tutto il cuore il perdono al boia, che chiede secondo l'usanza, ma vuole anche scambiare con lui un bacio. "E c'erano folle di persone lì, e tutti stavano quasi piangendo lacrime amare." Spesso i condannati erano nobili gentiluomini, e quindi il popolo riceveva dall'esecuzione di una giustizia inesorabile una soddisfazione ancora più vivida e una lezione ancora più crudele sulla fragilità della grandezza terrena di quanto qualsiasi rappresentazione pittorica della Danza della Morte potesse fornire. Le autorità hanno cercato di non perdere nulla per ottenere l'effetto dell'intera rappresentazione: segni dell'alta dignità dei condannati li hanno accompagnati durante questo lugubre corteo.
La vita quotidiana dava invariabilmente libertà infinita alle passioni ardenti e all'immaginazione dei bambini. La moderna scienza del Medioevo, che a causa dell'inattendibilità delle cronache si rivolge, per quanto possibile, prevalentemente a fonti di carattere ufficiale, cade così inconsapevolmente in un pericoloso errore. Tali fonti non evidenziano sufficientemente le differenze di stile di vita che ci separano dal Medioevo. Ci fanno dimenticare l'intenso pathos della vita medievale. Di tutte le passioni che lo coloravano, ce ne parlano solo due: l'avidità e la belligeranza. Chi non rimarrebbe stupito dalla furia e dalla costanza quasi incomprensibili con cui l'interesse personale, la litigiosità e la vendetta vengono alla ribalta nei documenti legali del tardo Medioevo! Solo in connessione con questa passione che ha travolto tutti, bruciando tutti gli aspetti della vita, si possono comprendere e accettare le aspirazioni caratteristiche di quelle persone. Ecco perché le cronache, anche se sfiorano la superficie degli eventi descritti e spesso forniscono anche informazioni false, sono assolutamente necessarie se vogliamo vedere questo momento nella sua vera luce.
La vita conservava ancora il sapore di una fiaba. Se anche cronisti di corte, nobili, dotti, stretti collaboratori dei sovrani, vedessero e raffigurassero quest'ultimo nient'altro che in una forma arcaica, ieratica, allora cosa dovrebbe significare il magico splendore del potere reale per l'ingenua fantasia popolare!
Comunità di cittadini. L'unicità delle città medievali dell'Europa occidentale era data dal loro sistema socio-politico. Tutte le altre caratteristiche - concentrazione della popolazione, strade strette, mura e torri, occupazioni dei cittadini, funzioni economiche e ideologiche e ruolo politico - potrebbero essere inerenti anche a città di altre regioni e altre epoche. Ma solo nell'Occidente medievale la città si presenta invariabilmente come una comunità autoregolamentata, dotata di un grado di autonomia relativamente elevato e in possesso di diritti speciali e di una struttura abbastanza complessa.
3.Cavalleria
La cavalleria è uno strato sociale privilegiato speciale della società medievale. Tradizionalmente, questo concetto è associato alla storia dei paesi dell'Europa occidentale e centrale, dove, durante il periodo di massimo splendore del Medioevo, essenzialmente tutti i guerrieri feudali secolari appartenevano al cavalierato. Ma più spesso questo termine viene usato in relazione ai signori feudali medi e piccoli in contrapposizione alla nobiltà. L'origine del cavalierato risale al periodo dell'alto medioevo (VII-VIII secolo), quando si diffusero forme condizionate di possesso fondiario feudale, prima permanente, poi ereditario. Nel trasferire la terra a un feudo, il concedente diventava un signore (suzerain), e il beneficiario diventava un vassallo di quest'ultimo, il che implicava il servizio militare (il servizio militare obbligatorio non superava i 40 giorni all'anno) e l'adempimento di alcuni altri compiti in favore del signore. Questi includevano un "aiuto" monetario nel caso in cui un figlio venisse nominato cavaliere, il matrimonio di una figlia o la necessità di riscattare un signore che era stato catturato. Secondo la consuetudine, i vassalli partecipavano alla corte del signore ed erano presenti al suo consiglio. La cerimonia di formalizzazione dei rapporti vassalli era chiamata omaggio e il giuramento di fedeltà al signore era chiamato foie. Se l'estensione delle terre ricevute per il servizio lo consentiva, il nuovo proprietario, a sua volta, ne cedeva parte in feudi ai suoi vassalli (subfeudazione). È così che ha preso forma un sistema di vassallaggio in più fasi ("sovranità", "gerarchia feudale", "scala feudale") dal signore supremo - il re ai cavalieri con scudo singolo che non avevano i propri vassalli. Per i paesi continentali dell'Europa occidentale, le regole delle relazioni vassalli riflettevano il principio: "il vassallo del mio vassallo non è il mio vassallo", mentre, ad esempio, in Inghilterra (giuramento di Salisbury del 1085) la dipendenza vassallo diretta di tutti i proprietari terrieri feudali dal il re fu introdotto con il servizio obbligatorio nell'esercito reale.
La gerarchia dei rapporti vassalli ripeteva la gerarchia delle proprietà terriere e determinava il principio della formazione della milizia militare dei feudatari. Pertanto, insieme all'instaurazione di rapporti militare-feudali, ebbe luogo la formazione del cavalierato come classe militare-feudale al servizio, che fiorì nei secoli XI-XIV. Gli affari militari divennero i suoi principali funzione sociale. La professione militare conferiva diritti e privilegi, determinava particolari visioni di classe, standard etici, tradizioni e valori culturali.
I doveri militari dei cavalieri includevano la protezione dell'onore e della dignità del signore supremo e, soprattutto, la terra dall'invasione sia dei vicini sovrani feudali nelle guerre intestine, sia delle truppe di altri stati in caso di attacco esterno. In condizioni di guerra civile, il confine tra la protezione dei propri beni e l'impossessamento delle terre altrui era piuttosto labile, e un paladino della giustizia a parole spesso si rivelava un invasore nella pratica, per non parlare della partecipazione alle campagne di conquista organizzate dal re. autorità, come le numerose campagne degli imperatori tedeschi in Italia, o dallo stesso Papa, come le Crociate. L'esercito cavalleresco era una forza potente. Le sue armi e le sue tattiche di battaglia corrispondevano ai compiti militari, alla portata delle operazioni militari e al livello tecnico del suo tempo. Protetto da armature militari in metallo, la cavalleria cavalleresca, poco vulnerabile ai fanti e alle milizie contadine, ha svolto il ruolo principale in battaglia.
Le guerre feudali non esaurirono il ruolo sociale della cavalleria. In condizioni di frammentazione feudale e di relativa debolezza del potere regio, la cavalleria, vincolata da un sistema di vassallaggio in un’unica corporazione privilegiata, proteggeva la proprietà fondiaria dei feudatari, base del loro dominio. Un esempio lampante Ciò può essere illustrato dalla storia della repressione della più grande rivolta contadina francese: la Jacquerie (1358-1359), scoppiata durante la Guerra dei Cent'anni. Allo stesso tempo, i cavalieri che rappresentavano le parti in guerra, inglesi e francesi, si unirono sotto le bandiere del re navarrese Carlo il Malvagio e rivoltarono le loro armi contro i contadini ribelli, decidendo una comune problemi sociali. Anche la cavalleria influenzò processi politici epoca, poiché gli interessi sociali della classe feudale nel suo insieme e le norme della moralità cavalleresca in una certa misura frenavano le tendenze centrifughe e limitavano i liberi feudali. Durante il processo di centralizzazione dello stato, i cavalieri (medi e piccoli signori feudali) costituirono la principale forza militare dei re nella loro opposizione alla nobiltà nella lotta per l'unificazione territoriale del paese e il potere reale nello stato. Questo fu, ad esempio, il caso della Francia del XIV secolo, quando, in violazione della precedente norma del diritto vassallo, una parte significativa dei cavalieri fu reclutata nell'esercito del re sulla base di un pagamento in denaro.
La partecipazione all'esercito cavalleresco richiedeva un certo livello di sicurezza e la concessione della terra non era solo una ricompensa per il servizio, ma anche una condizione materiale necessaria per la sua attuazione, poiché il cavaliere acquisiva sia un cavallo da guerra che costose armi pesanti (lancia, spada , mazza, armatura, armatura per il cavallo) a proprie spese, per non parlare del mantenimento del seguito corrispondente. L'armatura cavalleresca comprendeva fino a 200 parti e il peso totale dell'equipaggiamento militare raggiungeva i 50 kg; Nel tempo, la loro complessità e il loro prezzo sono aumentati. Il sistema di addestramento e istruzione cavalleresco serviva a preparare i futuri guerrieri. Nell'Europa occidentale, i ragazzi fino all'età di 7 anni crescevano in una famiglia; successivamente, fino all'età di 14 anni, venivano allevati alla corte di un signore come paggio, poi come scudiero, e infine si teneva una cerimonia farli cavalieri.
La tradizione richiedeva che il cavaliere fosse esperto in materia religiosa, conoscesse le regole dell'etichetta di corte e padroneggiasse le "sette virtù cavalleresche": equitazione, scherma, abile maneggio della lancia, nuoto, caccia, gioco di dama, scrittura e canto di poesie in onore della signora del cuore.
Il titolo di cavaliere simboleggiava l'ingresso in una classe privilegiata, la familiarità con i suoi diritti e responsabilità ed era accompagnato da una cerimonia speciale. Secondo l'usanza europea, il cavaliere che iniziava il grado colpiva l'iniziatore sulla spalla con il piatto della spada, pronunciava la formula di iniziazione, indossava un elmo e speroni d'oro, presentava una spada - simbolo della dignità cavalleresca - e uno scudo con l'immagine di uno stemma e di un motto. L'iniziato, a sua volta, prestava giuramento di fedeltà e si impegnava a sostenere un codice d'onore. Il rituale spesso terminava con un torneo cavalleresco (duello): una dimostrazione di abilità e coraggio militare.
Tradizioni cavalleresche e standard etici speciali si sono sviluppati nel corso dei secoli. Il codice d'onore si basava sul principio di lealtà al signore supremo e al dovere. Le virtù cavalleresche includevano il coraggio militare e il disprezzo per il pericolo, l'orgoglio, un atteggiamento nobile nei confronti delle donne e l'attenzione ai membri delle famiglie cavalleresche bisognose di aiuto. L'avarizia e l'avarizia furono condannate e il tradimento non fu perdonato.
Ma l’ideale non sempre corrispondeva alla realtà. Per quanto riguarda le campagne predatorie in terre straniere (ad esempio, la cattura di Gerusalemme o Costantinopoli durante le Crociate), le “gesta” cavalleresche portarono dolore, rovina, rimprovero e vergogna non solo alla gente comune.
Le Crociate contribuirono alla formazione di idee, costumi, moralità cavalleresca e all'interazione delle tradizioni occidentali e orientali. Durante il loro corso, in Palestina sorsero organizzazioni speciali di signori feudali dell'Europa occidentale per proteggere ed espandere i possedimenti dei crociati: ordini cavallereschi spirituali. Questi includono l'Ordine Giovannita (1113), l'Ordine Templare (1118) e l'Ordine Teutonico (1128). Successivamente operarono in Spagna gli ordini di Calatrava, Sant Iago e Alcantara. L'Ordine della Spada e del Livoniano è conosciuto nei Paesi Baltici. I membri dell'ordine prendevano voti monastici (non cupidigia, rinuncia alla proprietà, castità, obbedienza), indossavano abiti simili a quelli monastici e sotto di essi - armature militari. Ogni ordine aveva un proprio abbigliamento distintivo (i Templari, ad esempio, avevano un mantello bianco con una croce rossa). Dal punto di vista organizzativo, furono costruiti sulla base di una rigida gerarchia, guidata da un maestro eletto e approvato dal Papa. Sotto il maestro vi era un capitolo (consiglio) con funzioni legislative.
La riflessione della morale cavalleresca nel campo della cultura spirituale ha aperto la pagina più luminosa della letteratura medievale con il suo sapore, genere e stile speciali. Ha poeticizzato le gioie terrene nonostante l'ascetismo cristiano, ha glorificato l'eroismo e non solo ha incarnato gli ideali cavallereschi, ma li ha anche modellati. Insieme all'epica eroica dal suono altamente patriottico (ad esempio, la "Canzone di Roland" francese, la "Canzone del mio Cid" spagnola), apparve la poesia cavalleresca (ad esempio, i testi dei trovatori e dei trovatori in Francia e dei Minnesinger in Germania) e un romanzo cavalleresco (la storia d'amore di Tristano e Isotta), che rappresenta la cosiddetta “letteratura cortese” (dal francese courtois - cortese, cavalleresco) con il culto obbligatorio della dama.
In Europa, la cavalleria ha perso la sua importanza come principale forza militare degli stati feudali a partire dal XV secolo. Il presagio del declino della gloria della cavalleria francese fu la cosiddetta "Battaglia degli Speroni" (11 luglio 1302), quando la milizia a piedi dei cittadini fiamminghi sconfisse la cavalleria cavalleresca francese. Successivamente, l'inefficacia delle azioni dell'esercito cavalleresco francese fu chiaramente evidente nella prima fase della Guerra dei Cent'anni, quando subì una serie di gravi sconfitte da parte dell'esercito inglese. La cavalleria si rivelò incapace di resistere alla concorrenza degli eserciti mercenari che usavano armi da fuoco (apparvero nel XV secolo). Le nuove condizioni dell'era della decomposizione del feudalesimo e l'emergere delle relazioni capitaliste portarono alla sua scomparsa dall'arena storica. Nei secoli XVI-XVII. il cavalierato perde finalmente la specificità di classe speciale e diventa parte della nobiltà.
Rappresentanti delle antiche famiglie cavalleresche, cresciuti nelle tradizioni militari dei loro antenati, formarono il corpo degli ufficiali degli eserciti dell'era assolutista, intrapresero rischiose spedizioni marittime e realizzarono conquiste coloniali. La nobile etica dei secoli successivi, compresi i nobili principi di fedeltà al dovere e degno servizio alla patria, porta senza dubbio l'influenza dell'era cavalleresca.
4. Il significato della cattedrale in una città medievale
Cattedrale in una città medievale per molto tempo era l'unico edificio pubblico. Ha svolto il ruolo non solo di centro religioso, ideologico, culturale, educativo, ma anche amministrativo e, in una certa misura, economico. Più tardi apparvero i municipi e i mercati coperti, ai quali passarono alcune funzioni della cattedrale, ma anche allora essa non rimase affatto solo un centro religioso. L’idea che “i compiti principali della città…servissero base materiale e simboli delle forze sociali contrastanti che dominavano la vita urbana: il castello come sostegno del potere feudale secolare; la cattedrale è l'incarnazione del potere del clero; Il municipio è una roccaforte dell’autogoverno dei cittadini” (A.V. Ikonnikov) – è vero solo in parte. La loro accettazione incondizionata semplifica la vita socio-culturale della città medievale.
È abbastanza difficile per una persona moderna percepire la varietà di funzioni di una cattedrale medievale e il suo significato in tutte le sfere della vita cittadina. La cattedrale rimase un tempio, un edificio religioso, oppure divenne un monumento architettonico e culturale, un museo, una sala da concerto, necessaria e accessibile a pochi. La sua vita oggi non trasmette la pienezza della sua esistenza nel passato.
La città medievale era piccola e racchiusa da mura. I residenti lo hanno percepito in modo olistico, come un insieme, un sentimento perduto nella città moderna. La cattedrale definisce il centro architettonico e spaziale della città; con qualsiasi tipo di pianificazione urbanistica, il reticolo di strade gravitava verso di essa. Essendo l'edificio più alto della città, fungeva da torre di guardia, se necessario. La piazza della Cattedrale era la principale, e talvolta l'unica. Tutti gli eventi pubblici vitali si sono svolti o hanno avuto inizio in questa piazza. Successivamente, quando il mercato fu spostato dalla periferia alla città e apparve una speciale piazza del mercato, uno dei suoi angoli è spesso adiacente alla cattedrale. Ciò è accaduto in diverse città della Germania e della Francia: Dresda, Meissen, Naumburg, Montauban, Monpazier. In città, oltre alla cattedrale principale, di regola c'erano anche le chiese parrocchiali, e ad esse venivano trasferite alcune delle funzioni della cattedrale. Nelle grandi città il loro numero potrebbe essere significativo. Quindi una nota contemporanea a Londra alla fine del XII secolo. Centoventisei chiese di questo tipo.
La cattedrale appare ai nostri occhi ammirati in forma compiuta e “purificata”. Intorno ad esso non ci sono quelle piccole botteghe e panchine che, come nidi di uccelli, si aggrappavano a tutte le sporgenze e provocavano la richiesta da parte delle autorità cittadine e ecclesiastiche di “non fare buchi nei muri del tempio”. L'inadeguatezza estetica di questi negozi, a quanto pare, non ha disturbato affatto i contemporanei, sono diventati parte integrante della cattedrale e non hanno interferito con la sua grandezza. Anche la sagoma della cattedrale era diversa, poiché l'una o l'altra delle sue ali era costantemente situata nelle foreste.
La città medievale era rumorosa: in un piccolo spazio si sentiva lo scricchiolio delle ruote, il clangore degli zoccoli, il battito degli zoccoli di legno, le grida dei venditori ambulanti, il ruggito e il tintinnio delle botteghe artigiane, le voci e i campanacci degli animali domestici, che furono cacciati dalle strade solo gradualmente dalle autorità cittadine, e dai rantoli dei malati di lebbra. “Ma un suono invariabilmente soffocava il rumore di una vita inquieta: non importa quanto fosse vario, non si mescolava con nulla, elevando tutto ciò che accadeva nella sfera dell'ordine e della chiarezza. Questa è una campana che suona. Nella vita di tutti i giorni le campane erano paragonate all'avvertimento degli spiriti buoni che, con voci familiari a tutti, annunciavano dolore e gioia, pace e ansia, chiamavano la gente e avvertivano del pericolo imminente. Erano chiamati per nome: Roland, Fat Woman-Jacqueline - e tutti capivano il significato di questo o quello squillo. E sebbene le loro glosse risuonassero quasi incessantemente, l'attenzione al loro suono non era affatto offuscata” (J. Huizinga). La spighetta della cattedrale ha fornito a tutti i cittadini le informazioni necessarie contemporaneamente: su un incendio, sul mare, su un attacco o su qualsiasi evento di emergenza all'interno della città. E oggi gli antichi “Big Pol” o “Big Ben” animano lo spazio di una città moderna.
La cattedrale era la custode del tempo. Le campane scandivano le ore del servizio mattutino, ma per molto tempo annunciarono anche l’inizio e la fine del lavoro dell’artigiano. Fino al XIV secolo. - l'inizio della diffusione degli orologi meccanici da torre - era la campana della cattedrale a scandire il ritmo di una “vita ben ordinata”.
L'occhio vigile della chiesa accompagnava il cittadino dalla nascita alla morte. La chiesa lo accettò nella società e lo aiutò anche a trasferirsi nell'aldilà. I sacramenti e i rituali della Chiesa erano una parte essenziale della vita quotidiana. Battesimo, fidanzamento, cerimonia nuziale, servizio funebre e sepoltura, confessione e comunione: tutto ciò collegava l'abitante della città con la cattedrale o la chiesa parrocchiale (nelle piccole città la cattedrale era anche la chiesa parrocchiale), permettendogli di sentirsi parte della comunità cristiana società. La cattedrale fungeva anche da luogo di sepoltura per i cittadini facoltosi; alcuni avevano tombe di famiglia chiuse lì con lapidi. Ciò non era solo prestigioso, ma anche pratico (come notano gli storici, si verificavano costantemente rapine ai cimiteri parrocchiali).
Il rapporto tra i cittadini e il clero cittadino era tutt'altro che idilliaco. Le cronache di Guiberto di Nogent, Ottone di Freisingen, Richard Devize non dicono nulla di buono sugli abitanti della città. A sua volta, nella letteratura urbana - fabliau, schwanks, poesia satirica - il monaco e il prete vengono spesso ridicolizzati. I cittadini si oppongono alla libertà del clero dalle tasse; cercano non solo di liberarsi dal potere dei loro prelati signori, ma anche di sottomettere al controllo municipale gli affari che tradizionalmente erano sotto la giurisdizione della chiesa. Indicativa al riguardo è l'evoluzione della situazione degli ospedali, che nel corso dei secoli XIII-XIV. cessano gradualmente di essere istituzioni ecclesiastiche, pur conservando il patronato della chiesa e, quindi, l'inviolabilità dei loro beni. Tuttavia, la frequente opposizione al clero si combina con i costanti contatti con loro nella vita di tutti i giorni e non impedisce ai cittadini di considerare la costruzione e la decorazione della cattedrale la loro opera vitale.
Alla costruzione della cattedrale della città hanno preso parte non solo i cittadini, ma anche i contadini, i magnati e il clero circostanti. Le cronache medievali e altri documenti riflettevano esempi di entusiasmo religioso che stupirono i contemporanei: "donne, cavalieri, tutti cercarono non solo di donare, ma anche di aiutare la costruzione con tutta la manodopera possibile". Spesso venivano raccolti fondi in tutto il Paese per la costruzione della cattedrale. “Nel Medioevo si diffusero un'ampia varietà di donazioni, donazioni e contributi per la costruzione di un tempio, considerati un atto degno e benefico. Molto spesso si trattava di donazioni di gioielli e oggetti di valore, somme di denaro o fornitura gratuita di materiali per la costruzione futura” (K.M. Muratov). La costruzione della cattedrale richiese diversi decenni, ma il completamento completo dell'edificio richiese secoli. Di generazione in generazione, furono raccontate leggende sulla fondazione e la costruzione del tempio, furono raccolti sempre più fondi, furono fatte donazioni e lasciati testamenti. La frase del legato pontificio ed ex rettore dell'Università di Parigi, Odo de Chateauroux, secondo cui "la cattedrale di Notre Dame è stata costruita con i soldi delle povere vedove", ovviamente, non dovrebbe essere presa alla lettera, ma ci sono delle ragioni dietro. Un sincero impulso di pietà si univa alla rivalità con la città vicina e, per alcuni, al desiderio di ricevere l'assoluzione personale. La bellissima cattedrale era uno degli importanti segni di prestigio, a dimostrazione della forza e della ricchezza della comunità cittadina. Le dimensioni dei templi costruiti in città molto piccole, il lusso e la complessità dei loro interni soddisfano la necessità di creare qualcosa di incommensurabile in bellezza e grandezza con tutto ciò che lo circonda. L'importanza della cattedrale è testimoniata anche dalla volontà di restaurarla subito dopo l'incendio, e sicuramente nello stesso luogo, per preservare i consueti oggetti di pellegrinaggio.
La costruzione della cattedrale fu per molti anni al centro dell'attenzione dei cittadini, ma entrò in funzione molto prima del suo completamento definitivo. La costruzione iniziò con la parte del coro; il tetto veniva solitamente costruito anche prima che il tempio fosse coperto con le volte, in modo che il culto potesse essere celebrato abbastanza rapidamente dopo l'inizio della costruzione.
eccetera.................
RELAZIONI FAMILIARI. Nell'alto Medioevo, una famiglia di coppia - genitori con figli - di solito non era percepita come indipendente ed era inclusa in una cerchia più ampia di parenti e di tutti coloro che vivevano sotto lo stesso tetto, compresi i servi.
Dal IX secolo Cominciano a venire portati i sacerdoti per benedire gli sposi. Nell'XI secolo, non senza l'influenza della chiesa, una piccola famiglia di coppie cominciò a essere percepita come l'unità principale. Da quel momento in poi l'influenza della chiesa sulla famiglia aumentò, il matrimonio in chiesa divenne il rito principale della sua creazione, sebbene divenne obbligatorio solo nel XIII secolo. Ma anche più tardi persistette una convivenza non santificata dalla chiesa, soprattutto tra i contadini, sebbene i figli nati da tali rapporti fossero spesso considerati illegittimi.
I sentimenti non erano la base della famiglia, ma la sua aggiunta. La Chiesa vedeva l'essenza del matrimonio solo nella continuazione della razza umana. La passione era condannata perché allontanava dall'amore per Dio. Pertanto, l'atteggiamento ardente del marito nei confronti della moglie era classificato come un peccato, una sorta di dissolutezza.
Si sono sposati presto. Secondo le regole della chiesa, lo sposo doveva avere 14 anni, la sposa - 12. La scelta dei coniugi, soprattutto se minorenni, veniva effettuata dai genitori in base a considerazioni economiche o di prestigio.
Una donna nella famiglia, così come nella società, occupava una posizione umiliata, che era in gran parte basata sull'idea della chiesa di lei come un'esca di Satana, uno strumento di tentazione e di caduta, che proveniva dai monasteri. Le donne nel Medioevo non erano percepite come individui indipendenti, nemmeno dalla maggior parte di loro stesse. La partecipazione delle donne alla vita pubblica era consentita solo attraverso il monachesimo. Gli aristocratici, in quanto badessa, potevano ottenere ed esercitare i diritti al potere. È significativo che l’adulterio della moglie fosse quasi sempre considerato motivo di divorzio, ma l’infedeltà del marito no.
D’altro canto, lo sviluppo dell’economia urbana ha, in alcuni casi, migliorato la condizione delle donne. A poco a poco, nelle città si svilupparono una serie di professioni e occupazioni femminili: tessitura, filatura, panificazione, produzione di birra, gestione di taverne. Tuttavia, la discussione sull’alfabetizzazione delle donne continuò fino alla fine del Medioevo (gli uomini dovevano leggere a casa).
Lo sviluppo della famiglia nel Medioevo si rifletteva in modo univoco nei cambiamenti di progettazione sepolture. Dai secoli V-VI. la famiglia e i bambini scompaiono dalle lapidi, così come le stesse immagini delle lapidi. Le lapidi compaiono di nuovo nei secoli XI-XII, ma marito e moglie vengono sepolti separatamente e i bambini non sono affatto raffigurati. Le sepolture congiunte dei coniugi sono state notate fin dal XIV secolo. Allo stesso tempo compaiono immagini di bambini, ma senza indicarne l'età o parole di dolore. Nel XVI secolo. Appaiono iscrizioni sul dolore dei genitori e le immagini di un bambino specifico compaiono solo nel XVII secolo.
In condizioni in cui quasi la maggioranza dei bambini moriva durante l'infanzia e quasi la metà delle donne moriva durante il parto, quando le epidemie distruggevano tutti, quando una rara ferita guariva e quando quasi più di una cicatrice non guariva, quando sia la vita stessa che la Chiesa insegnavano farci pensare costantemente alla morte, i pensieri a riguardo erano quotidiani, familiari. Fino al XIII secolo. In generale, si credeva che prima della seconda venuta di Cristo e del Giudizio Universale, le persone non morissero, ma si addormentassero. Solo con la complicazione della vita, soprattutto nelle città, già dal XII secolo. c'è la paura della morte. E dal 13 ° secolo. l'idea del sonno prima del Giudizio Universale viene sostituita dal concetto del Purgatorio, in cui dopo la morte si determina dove risiederà l'anima, in paradiso o all'inferno.
Lo sviluppo della famiglia è evidenziato storia dei nomi. Il cristianesimo ha limitato la scelta dei nomi Santi(calendario della chiesa con i nomi dei santi venerati dalla chiesa in un determinato giorno). Di conseguenza, c'erano meno nomi. Inoltre la nobiltà si unì ben presto a questa tradizione, che la distingueva dal resto della popolazione. Ma apparvero rapidamente molti nomi identici, il che portò alla nascita di cognomi apparsi nell'Europa occidentale nel XII secolo. dai soprannomi.
CONCETTI SUL TEMPO. Nell'Europa medievale veniva utilizzato un calendario solare, nato tra gli antichi popoli agricoli dalla necessità di determinare l'inizio dei lavori nei campi dal sole. Nel Medioevo, gli europei usavano Calendario giuliano. Ma non era del tutto esatto. La durata accettata dell'anno solare medio superava quella reale così tanto che un errore di 1 giorno si accumulava su 128 anni. Di conseguenza, il momento dell’effettivo equinozio di primavera non coincide più con il calendario. Questo era di fondamentale importanza per i calcoli pasquali. L'errore fu scoperto nel Medioevo, ma solo nel XVI secolo, quando l'errore era già di 10 giorni, fu creata una commissione sotto Papa Gregorio XIII per riformare il calendario. Di conseguenza, ne apparve uno nuovo, calendario gregoriano, in cui un errore di 1 giorno si accumula in 3280 anni. Per decreto papale, il 6 ottobre 1582 doveva essere seguito dal 15 ottobre. Ma il passaggio al nuovo calendario, a causa del ponderato conservatorismo delle persone, fu ritardato anche nell’Europa occidentale e nel XVII secolo.
Il Medioevo vide l'istituzione di un'altra caratteristica temporale – Era cristiana. Fu introdotto nel 525 dal monaco romano Dionigi il Piccolo, che calcolò la data di nascita di Cristo (753 dalla fondazione di Roma). Nei documenti, il concetto di “era cristiana” cominciò ad essere utilizzato nel VII secolo. Ma solo dal XV secolo. tutti i documenti papali ricevevano una data dalla Natività di Cristo, e questa cronologia divenne universale solo nel XVIII secolo.
Anche la settimana di sette giorni nel Medioevo fu presa in prestito dagli antichi, dai romani, i nomi dei giorni della settimana arrivarono anche nell'Europa medievale. Inizialmente i cristiani, come gli ebrei, celebravano il sabato come un giorno dedicato a Dio. Ma nel II secolo. il giorno del riposo fu spostato nel giorno del Sole e l'imperatore Costantino legalizzò questa festa. I Carolingi resero obbligatoria questa tradizione in tutto l'impero, dichiarando la domenica giorno di riposo e di preghiera.
L’uomo medievale era generalmente quasi indifferente al tempo, a causa della routine generale della vita, della sua monotonia e del legame dell’uomo con il ritmo naturale. Il tempo non si sentiva, non se ne prendeva cura, anche se non vivevano a lungo, in media, fino a 30-35 anni. Si credeva che il tempo fosse proprietà di Dio; l'uomo non ha potere sul tempo.
Tuttavia, con la lentezza e la lentezza della società nel suo insieme, con il lento scorrere della vita, dipendente dai cicli naturali, le persone sono cresciute rapidamente e hanno realizzato rapidamente le proprie capacità: una breve aspettativa di vita sembrava comprimere il tempo e all'età di 25 anni 30 persone hanno realizzato molto. Ciò vale soprattutto per i vertici della società: giovani re, duchi, vescovi, ecc. La vecchiaia è iniziata con l’età adulta moderna. Il mondo medievale era governato dai giovani. Ma l'idea della chiesa - tutti sono mortali - ha portato alla mancanza di sete di vita.
MOVIMENTO. Era piacevole come il passare del tempo. In una giornata solitamente percorrevano solo poche decine di chilometri. Viaggiavano così tranquillamente non solo perché non conoscevano il valore del tempo. Ci spostavamo per lo più a piedi, perché andare a cavallo era costoso. Spesso gli aristocratici che andavano a cavallo erano accompagnati da servi a piedi, ad es. Il pilota non aveva alcun vantaggio in termini di velocità. Ma viaggiare a cavallo era più comodo e rifletteva una certa stato sociale viaggiatore Quelli. la velocità media di movimento nel Medioevo era determinata dalla velocità di un pedone e raramente superava i 30 km.
Le strade erano in pessime condizioni. Prima di tutto erano stretti, più simili a sentieri. In inverno e quando piove diventano impraticabili. Le strade in Francia furono migliorate, grazie all'introduzione delle tasse stradali da parte di re e monasteri. C'erano pochi ponti ed erano fragili. I ponti in pietra iniziarono a essere costruiti nel XIII secolo. I fiumi erano più convenienti per il movimento: le "strade di Dio", come venivano chiamate allora.
In generale, le strade medievali non possono essere viste da un punto di vista moderno. Avevano poi altre funzioni, perché la maggior parte delle persone si spostava a piedi o a cavallo, il che non richiedeva grandi spese per la loro copertura rigida. Camminata comoda e buona visibilità: questo era tutto ciò che veniva loro richiesto.
La circolazione era ostacolata dalla situazione di tirannia feudale: dazi doganali, percorsi obbligatori per i mercanti, che venivano determinati dai feudatari nei loro domini (il percorso veniva spesso allungato appositamente per riscuotere dazi aggiuntivi), pagamento del convoglio obbligatorio, che il feudatario i signori dovevano provvedere. Anche se più spesso prendevano soldi per la protezione e rilasciavano il certificato corrispondente. Ma sarebbe sbagliato concludere che le strade fossero quasi sempre deserte. Abbiamo viaggiato molto. La mancanza di comunicazioni affidabili richiedeva contatti personali: molti re letteralmente non scendevano dalla sella. I signori feudali si spostavano spesso di tenuta in tenuta: sia per il controllo che per consumare le provviste: era più facile venire di persona che trasportare il cibo. Commercianti e venditori ambulanti si recavano lì a causa della mancanza di acquirenti.
CONNESSIONE. Lo stato descritto delle vie di comunicazione faceva sì che le lettere impiegassero mesi per essere consegnate. Un ostacolo allo sviluppo dei servizi postali era l'analfabetismo generale.
Nel 12 ° secolo. la corrispondenza si fece più intensa e si scrissero soprattutto lettere d'amore e religiose. Dal 13 ° secolo Si diffuse anche la corrispondenza commerciale. Ma va notato che anche le persone istruite spesso dettavano le loro lettere, perché scrivere era un compito complesso e ad alta intensità di manodopera. Il servizio postale fu istituito solo nel 1490 dall'imperatore Federico III d'Asburgo.
IGIENE La popolazione medievale era ad un livello molto basso. Era quasi impossibile lavarlo a causa della mancanza di sapone e, successivamente, a causa del suo costo elevato. La maggior parte dei popoli europei non conosceva asciugamani o fazzoletti; fino ai secoli XIII-XIV. Mancava anche la biancheria intima. I piatti erano comuni, si beveva da coppe comuni e prendevano il cibo con le mani, tirandolo fuori da una pentola comune.
In molte città, i maiali vagavano per le strade, gatti e cani morti giacevano in giro. Anche nel tardo Medioevo non esistevano quasi condutture idriche: spesso l'acqua era imbevibile. Dove c'erano cisterne per l'acqua, spesso galleggiavano anche i cadaveri di gatti e ratti. Le acque reflue dei pozzi neri spesso finivano nei pozzi vicini. I cimiteri erano solitamente situati vicino alle chiese e poiché le chiese si trovavano, di regola, nei centri degli insediamenti, i prodotti di decomposizione avvelenavano l'aria e, soprattutto, il suolo e le acque sotterranee. La brodaglia veniva solitamente versata in strada. Anche nel XVIII secolo. in Francia i vasi da notte venivano rovesciati dalle finestre.
Ma gradualmente, soprattutto con lo sviluppo delle città, si iniziarono ad adottare misure per migliorare le condizioni sanitarie. Dal 12 ° secolo in Italia si emanano editti per il miglioramento delle città e si introducono controlli sui prodotti venduti. Allo stesso tempo, in Inghilterra e Germania apparvero medici governativi e guardiani del mercato. Ma la rinascita dell'igiene (al livello antico) iniziò nei secoli XVI-XVII, quando apparvero gli epidemiologi.
NUTRIZIONE ha influito anche sullo stato di salute. Il cibo medievale era monotono; solo la nobiltà e i ricchi cittadini potevano diversificare il loro menu. Gli altri soffrivano innanzitutto di carenza di proteine (mangiavano carne raramente, di solito durante le vacanze). Non c'era quasi zucchero. Lo zucchero di canna fu scoperto dagli arabi nel X secolo. in Italia, ma a causa del suo costo elevato, veniva utilizzato solo dagli aristocratici, mentre altri lo usavano come medicinale. La dolcezza principale era il miele. Anche l'olio vegetale, diffuso solo nel Mediterraneo, era poco utilizzato.
La mancanza di valore nutrizionale è stata compensata dalla quantità. Mangiavano soprattutto molto pane. Consumavano poche verdure, il che portava ad una carenza di vitamine. Il consumo di verdure e carne è aumentato a partire dal XIV secolo, il che, tra l'altro, ha causato un aumento della richiesta di sale, necessario per conservare carne e pesce. Il sale sta diventando uno dei principali prodotti del commercio, compreso il commercio internazionale. Dal 14 ° secolo inoltre al posto dello strutto fuso si spandeva burro, che ha contribuito allo sviluppo dell'allevamento lattiero-caseario nei paesi lungo la costa del Mare del Nord. Allo stesso tempo, negli stagni si cominciò ad allevare pesci d'acqua dolce, cosa assicurata dalla costante domanda di pesce veloce il venerdì e durante la Quaresima. A questo punto, i cristiani avevano già imparato a coniugare in qualche modo la fedeltà alla fede e abitudini di convenienza e conforto già consolidate.
Ma il cibo mancava di piccante: la mancanza di spezie veniva sostituita con salse all'aglio e alla cipolla, aceto e senape. La carne veniva solitamente servita sotto forma di spezzatino con condimenti a base di radici, fagioli ed erbe aromatiche. Per un migliore assorbimento, i cibi grassi di grandi dimensioni venivano lavati con abbondante acqua. Bevevano molto, un litro e mezzo di vino o birra a persona al giorno.
Nel XIV secolo non c'erano forchette. lo consideravano ancora un lusso sfrenato. Anche i cucchiai venivano usati raramente. I più popolari erano i coltelli e le proprie dita. Anche nelle case nobiliari le mani venivano solitamente asciugate sulla tovaglia.
ASSISTENZA SANITARIA in epoca medievale era poco sviluppato. Non solo nelle zone rurali, ma anche in molte città non c’erano medici. I rari ospedali, che spesso ospitavano diversi pazienti in un letto, erano serviti da monaci e monache che non avevano una formazione medica specifica.
Ma la medicina si è comunque sviluppata. Dalla fine del XII secolo. apparvero gli ospedali privati. Allo stesso tempo, nelle città iniziarono a essere fondati ospedali per i “loro” poveri (cioè solo per i residenti legali di una determinata città). Dal 14 ° secolo Sono segnalati gli ospedali comunali, ma solo per i cittadini che pagavano una tariffa speciale. A volte tali ospedali possedevano terre e villaggi.
La ricerca scientifica era poco sviluppata. Il Concilio Lateranense del 1139 proibì ai medici del monastero di eseguire operazioni, e nel 1163 apparve un rescritto della chiesa che vietava l'insegnamento della chirurgia a causa della sua interferenza con i misteri di Dio. Questi divieti hanno contribuito all'emergere di medici laici.
L'imperatore Federico II Staufen fece molto nell'organizzazione della medicina civile: sostenne la Scuola dei Medici di Salerno (in Sicilia), le diede una Costituzione (Carta), secondo la quale l'educazione medica consisteva in una formazione preliminare di tre anni in scienze generali, poi uno studio quinquennale sulla medicina secondo Ippocrate e Galeno e anni di lavoro sotto la guida di un medico esperto. A Salerno le farmacie erano iscritte in un apposito elenco; ai privati era proibito produrre medicinali, filtri d'amore e veleni.
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO. Il principale tipo di intrattenimento medievale nell'Europa occidentale era ballare, comune a tutti i livelli della società e associato alla musica strumentale secolare. Le danze negli strati superiori della società contrastavano nettamente con le danze frenetiche e focose dei ballerini. Sebbene fondamentalmente avessero gli stessi elementi, venivano eseguiti in modo più sobrio, in conformità con l'etichetta. Gli atteggiamenti nei confronti della danza nella società variavano. I moralisti non distinguevano le ballerine dalle voluttuose cortigiane: una donna che iniziava a ballare era ovviamente svergognata. Sono state conservate numerose immagini in cui le donne danzanti simboleggiavano vari vizi e accompagnavano persino i peccatori all'inferno. Capelli scoperti e fluenti e acconciature abili furono paragonate dai chierici a lingue di fuoco infernale e considerate uno dei mezzi di tentazione diabolica.
Ma i giocolieri non erano famosi solo per la loro danza. Gli artisti erano interpreti, e spesso autori, di parodie di ogni genere: sia su diversi aspetti della vita dell'epoca, sia sulle persone, sia nei loro gruppi sociali (nobili, clero, ecc.) che personalmente. Inoltre, nelle condizioni del corporativismo medievale, uno stile di vita errante destava di per sé sospetti. Inoltre, questa posizione degli artisti escludeva il controllo quotidiano su di loro, il che contraddiceva anche le norme di vita di quel tempo.
Tra gli intrattenimenti occupava un posto di rilievo Giochi. Nel XIII secolo. A Parigi e Novgorod era noto un gioco simile all'hockey: la palla veniva fatta girare come un bastone. Da allora sono note le slitte con pattini ricavati dalle mascelle dei cavalli. Tra questi ci sono i pattini, utilizzati sin dal XIII secolo. apparvero anche guide di metallo. Del XIII/XIV secolo. In Francia iniziarono a giocare a bocce. Poi è apparso il gioco del volano: con l'aiuto delle assi hanno lanciato una palla con piume. Dal 14 ° secolo Il calcio è apparso nella campagna inglese. Il gioco dei dadi è diffuso fin dall'antichità. La sua popolarità dipende dall'occasione, che era abbastanza coerente con la visione del mondo medievale. Quelli apparsi nel XV secolo divennero più raffinati. carte che mantengono lo stesso principio di casualità. Diffusione nei secoli XI-XIII. gli scacchi erano il gioco dei nobili.
In realtà nel Medioevo mancavano i divertimenti. Il basso livello di istruzione richiedeva innanzitutto un semplice intrattenimento: spettacoli, la cui sete è uno dei bisogni più importanti dell'uomo medievale. La sete di spettacolo rese popolari le esecuzioni pubbliche. Ma l'interesse, a volte malsano, per le esecuzioni capitali era suscitato anche dalla generale rozzezza dei costumi, meno sensibile di adesso, determinata da uno stile di vita più duro: freddo nelle case, notti buie per scarsa illuminazione, caccia diffusa non solo per divertimento. o per procurarsi cibo, ma e per proteggersi dai predatori.
ATTEGGIAMENTO VERSO IL LAVORO. Nell'alto medioevo il lavoro principale del contadino era. Ma era considerata bassa anche l'occupazione di persone dipendenti, servi. La maggior parte dei mestieri dell'Alto Medioevo erano considerati “bassi”. In generale, le società precapitaliste erano estranee al desiderio del lavoro quotidiano, tranne forse per procurarsi il pane quotidiano. Ma non per accumulare ricchezza. Altri modi erano comuni per questo: servizio giudiziario o militare, eredità, usura, alchimia. Ecco perché a loro non piacevano i mercanti: i contadini non si fidavano di loro e la nobiltà era gelosa.
A cavallo tra il X e l'XI secolo iniziò una svolta nell'atteggiamento nei confronti del lavoro, associata alla nascita delle città e allo sviluppo dell'artigianato indipendente. Con l'avvento di nuove professioni, il numero di occupazioni indesiderate viene gradualmente ridotto: i loro benefici vengono presi in considerazione. Il prestigio dell'opera aumentò gradualmente. E se prima la Chiesa considerava il lavoro come pentimento dei peccati, ora emerge il concetto ecclesiale di lavoro come mezzo di autosufficienza e salvezza attiva dell'anima. Una caratteristica della mentalità urbana è che è diventato spudorato arricchirsi. Un ricco abitante della città (padrone, commerciante) non viene più umiliato come prima. Lui “si fa”; questo ha contribuito a superare il tradizionalismo e l’arcaismo in Europa.
RUOLO E POSTO DELLA RELIGIONE NELLA VITA QUOTIDIANA. Nei secoli X-XI. L'influenza dei monasteri sulla società aumenta, ma si intensifica anche il processo di secolarizzazione del clero, poiché il clero più alto veniva reclutato dall'ambiente feudale, quello inferiore dai contadini. Dal X secolo Nell’Europa occidentale si è diffusa una divisione tripartita della società in “coloro che pregano, coloro che lottano e coloro che lavorano”. Il clero in questo sistema veniva prima.
Anche nel XIII secolo. a causa dell'incapacità di pensiero astratto causata dall'analfabetismo, i laici assimilarono maggiormente il lato emotivo del cristianesimo. La religione rimase per loro al livello dei rituali e dei gesti, delle visioni e della fede nei miracoli. Il latino ha interferito con la percezione dei fondamenti teologici del cristianesimo. La Chiesa cercava di mantenere e rafforzare la religiosità delle masse e prestava grande attenzione al pentimento, al quale tutti i credenti erano regolarmente tenuti a sottoporsi. Per valutarli venivano usati speciali libri penitenziali. Raccolsero i peccati tipici e diedero consigli ai sacerdoti sulle punizioni da imporre per determinati peccati.
VISTE GIURIDICHE. Nel Medioevo la parola legge usato raramente, più spesso - Giusto, diritti, giustizia. C'erano frequenti riferimenti a documenti legali a costume. Le antiche usanze erano particolarmente apprezzate. Tra le forme di testimonianza nell'alto medioevo erano comuni prove- processi giudiziari, durante i quali l'accusato doveva dimostrare la sua innocenza durante il rituale - "tribunale di Dio", che durò fino al XIII secolo.
Con la sostituzione dei processi giudiziari con la pratica dell'inchiesta, la pratica dell'inchiesta si è diffusa tortura. Dal 13 ° secolo si credeva che il criminale avesse un'anima debole. Non riesce a gestire il suo corpo. Pertanto, è necessario torturare il corpo per sconfiggere la verità.
Le punizioni comprendono multe pecuniarie (anche per omicidio), punizioni vergognose e corporali, reclusione a pane e acqua (se il condannato non ha soldi). Pene comuni incluse la pena di morte. L'esecuzione è stata eseguita secondo un rituale rigoroso, che ha dimostrato il trionfo della legge. Nei secoli XIV-XV. cominciò gradualmente a essere creato sistema di indagine penale, il che significava il passaggio della repressione della criminalità dalla popolazione allo Stato.
Dal 12 ° secolo si diffondono idee di legge naturale, la cui fonte è la natura (insieme a Dio). Iniziò così la separazione della coscienza giuridica dalla religione. L’idea dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge e al diritto naturale, che può opporsi al proprio diritto personale, penetra nella società dell’Europa occidentale: c’è la consapevolezza che gli altri riconoscono destra- Abbiamo bisogno di un accordo. Entro il XIV secolo È già riconosciuto che tutti dovrebbero averlo destra, che è generalmente accettato. Da qui, in combinazione con le idee religiose sulla moralità, nascono le idee sull'ordine generale.
Nel XIV secolo C'è anche un ritorno completo al diritto romano. Il concetto di legge naturale lo distingue dalla moralità, perché ci sono anche dei vizi nella natura umana; la maggior parte delle persone non è abbastanza virtuosa. Poiché sono corrotti, non possono vivere secondo il diritto di Dio. Vita morale richiede uno sforzo da parte loro. Pertanto, le persone hanno bisogno delle leggi civili (non di Dio). Da qui l'incremento nei secoli XIV-XV. il ruolo della magistratura e degli avvocati.
Dal 14 ° secolo Si sta diffondendo l'idea della sovranità reale: il diritto di legiferare. Insultare il re è considerato un crimine di stato. Ma ciò aumentò la dipendenza dei sudditi dai re. Per il bene pubblico, i re ricevono anche il diritto di confisca. Cioè, i re si trasformano in portatori del diritto comune. La nuova dottrina monarchica limitò anche il diritto privato. Ma l’idea della sovranità popolare, sebbene indebolita, non morì, preservandosi nel governo cittadino. Essa venne ripresa e vinta durante le rivoluzioni borghesi.
Non importa quanto fossero importanti per gli stati latini di Lenant gli aspetti militari e religiosi dell'esistenza e i contatti con il mondo musulmano circostante, i problemi della vita pacifica e della garanzia della vita quotidiana occupavano un posto altrettanto significativo. Subito dopo la sanguinosa ondata di conquiste, divenne chiaro che l’omicidio e il terrore non erano il modo migliore per garantire la stabilità e la vitalità dei nuovi Stati. Gli stessi Franchi non ebbero la possibilità di stabilirsi in questi paesi proprio a causa delle peculiarità del pellegrinaggio “di combattimento”: dopotutto, la maggioranza assoluta dei partecipanti alle crociate, dopo aver adempiuto al proprio dovere di pellegrini, lasciò la Terra Santa. E quelle migliaia, anche decine di migliaia di soldati cattolici rimasti, non potevano affatto sostituire milioni di persone. Inoltre, gli stessi conquistatori avevano bisogno di sudditi, avevano bisogno di denaro e cibo per l'esercito. Pertanto, subito dopo la Prima Campagna, soprattutto a partire dal 1110, quando il nuovo governo fu sufficientemente rafforzato, l'atteggiamento nei confronti della popolazione conquistata cambiò notevolmente.
È importante notare che i paesi del Mediterraneo orientale si distinguevano per un'eccezionale diversità nazionale e religiosa. Circa la metà della popolazione era musulmana (nel Regno di Gerusalemme la loro percentuale era ancora più alta). E nel Principato di Antiochia la maggior parte degli abitanti erano greco-ortodossi.
La contea di Edessa e la Cilicia orientale erano prevalentemente armene. Le regioni montuose e le valli del Libano erano abitate sia da cristiani maroniti* che da drusi** che si erano separati gli uni dagli altri. A tutto ciò si aggiungevano un numero considerevole di ebrei giudaici e, nel montuoso nord-est, anche persiani adoratori del fuoco. Se si tiene conto del fatto che gli stessi musulmani erano divisi in ismailiti, dodicesimi sciiti e sunniti ortodossi***, il quadro diventa estremamente eterogeneo.
Bisogna ammettere che i nuovi sovrani hanno affrontato abbastanza bene il compito di ristabilire l'ordine nei territori conquistati. Si basava su un principio antico quanto il mondo, chiaramente formulato già nell’antica Macedonia: “divide et impera”. L'intera popolazione era chiaramente divisa in base ai privilegi o, al contrario, alle restrizioni, alle tasse pagate e allo status giuridico. Allo stesso tempo, le autorità hanno cercato di non interferire nella vita interna di queste comunità, chiedendo solo il rispetto della legislazione generale. I signori franchi non interferirono con i costumi e l'autogoverno locali; Inoltre, ogni gruppo sociale aveva il suo norme legali. Quindi, ad esempio, i musulmani giudicavano secondo la legge della Sharia - ovviamente anche i giudici erano musulmani. Naturalmente, la giurisdizione più alta apparteneva ai conquistatori, la cui corte giudicava crimini che andavano oltre i confini di una particolare comunità (ad esempio, una causa tra un musulmano e un greco ortodosso) o crimini particolarmente gravi. Per il resto, questi diversi gruppi erano praticamente autonomi.
*I Maroniti sono una setta cristiana orientale sorta intorno al V secolo. Nel 1181 si sottomisero alla sede apostolica, ma conservarono una certa autonomia interna.
** I drusi sono un movimento eretico dell'Islam fondato dal sultano egiziano al-Hakim, che si dichiarò dio vivente intorno al 1017. Si rifiutarono di praticare la Shahada, escludendosi così dalle fila dei musulmani; erano ostili anche all’Islam.
***Vedi capitolo 3.
La parte più privilegiata dei sudditi erano, ovviamente, i crociati stessi e i loro discendenti. Quasi tutti, ad eccezione di una piccola parte dei servi dei feudatari, godevano della libertà personale, compresa la completa libertà di movimento e di insediamento. In generale, questi ex contadini, che per volontà del destino divennero guerrieri, occuparono nel Levante un posto che non ha analoghi nel sistema di classi europeo di quel tempo. Lì prevaleva una gradazione abbastanza chiara di tre livelli: coloro che pregavano - cioè il clero, coloro che combattevano - i cavalieri e i lavoratori - i contadini. La crescita delle città, ovviamente, iniziò a complicare questo ordine: l'artigianato e il commercio si allontanarono significativamente dal lavoro rurale. Tuttavia l’appartenenza dei commercianti e degli artigiani alla classe operaia era fuori dubbio. Ma con i crociati della prima ondata e i loro discendenti la situazione era più complicata. Da un lato erano senza dubbio lavoratori che si nutrivano del proprio lavoro. Alcuni di loro diventavano affittuari dei feudatari, solitamente a condizione di pagare la decima del raccolto**. L'altra parte, quella più piccola, fino alla fine del XII secolo, si stabilì nelle città. Ma, d'altra parte, i conquistatori cattolici costituivano una minoranza insignificante in Terra Santa, vivendo in mezzo a una popolazione ostile (o, nella migliore delle ipotesi, neutrale) che li superava decine di volte. E i feudatari furono costretti ad attirarli costantemente come forza militare per guerre infinite. Cioè, erano entrambi allattanti e militari allo stesso tempo.
Il conflitto per una società medievale rigidamente strutturata era, infatti, quasi senza precedenti. Solo come analogia molto incompleta, e anche successiva, si possono citare gli yeomen inglesi o i single-lords russi. Eppure i piccoli proprietari terrieri rimanevano legalmente contadini, mentre i nobili, nonostante il loro effettivo lavoro contadino, appartenevano alla nobiltà. Per i crociati di origine non nobile non fu mai determinato uno status giuridico chiaro: rimasero un intermediario gruppo sociale. E dalla fine del XII secolo questo problema giuridico cominciò gradualmente a svanire. Le conquiste di Saladino costrinsero quasi tutti i cattolici a trasferirsi nelle città, e dopo la morte di Saladino iniziò un periodo di pace di mezzo secolo e scomparve la necessità di un servizio militare costante. Tuttavia, va notato che la linea che in Europa separava completamente la nobiltà dai contadini era in gran parte sfumata in Terra Santa, e durante gli anni delle Crociate molti di questi “signori single cattolici” entrarono nei ranghi del cavalierato.
Tra la popolazione conquistata, i cristiani di varie convinzioni avevano uno status più elevato; Inoltre, prima della rottura con Bisanzio all'inizio del XIII secolo, la posizione dei greci ortodossi era la migliore. Godevano di alcuni benefici fiscali e talvolta venivano reclutati nell'esercito. Più complessi furono i rapporti con gli Armeni monofisiti*, ma in generale gli Armeni rimasero un gruppo privilegiato. Inoltre, i nobili crociati sposarono volentieri rappresentanti della nobiltà armena, ei principi armeni sposarono le figlie dei signori e dei cavalieri franchi. Ciò era particolarmente evidente nella contea di Edessa, che già negli anni Trenta del XIII secolo era diventata una prospera enclave franco-armena al di là dell'Eufrate.
La maggior parte della popolazione si trovava in una posizione meno vantaggiosa. I musulmani erano soggetti a tasse molto più elevate, che andavano dal 30 al 50%, a seconda della zona e del raccolto coltivato. Inoltre era loro vietato vivere a Gerusalemme e in alcune città portuali. Allo stesso tempo, la loro situazione non era particolarmente difficile e per molti aspetti era addirittura migliore che sotto il governo di altri musulmani. È interessante, a questo proposito, la testimonianza dell'implacabile nemico dei crociati, il viaggiatore di schiavi Ibn Ju-bayr, che intorno al 1184 scrisse quanto segue: “Ci siamo spostati da Tibnin lungo la soglia, lungo la quale si estendevano le fattorie dove vivono i musulmani, vivere in grande prosperità sotto i Franchi - Che Allah ci protegga da una tale tentazione... I musulmani sono i proprietari delle loro case e si governano come capiscono... I cuori di molti musulmani sono pieni della tentazione di stabilirsi lì (in le terre franche) quando vedono la situazione dei loro fratelli nelle zone governate dai musulmani, perché la loro condizione è ben lungi dall'essere prospera. Sfortunatamente per i musulmani, nei paesi dove governano i loro correligionari, si lamentano sempre dell’ingiustizia dei loro governanti, ma criticano il comportamento dei Franchi, della cui giustizia non possono che essere orgogliosi”.
Alle parole di ibn Jubayr fa eco il famoso poeta e scienziato arabo Osama ibn Munkyz, che teme seriamente anche il reinsediamento di massa dei musulmani sotto il dominio dei crociati. Osama, che non è affatto amichevole con i Franchi, elogia l'equità della loro giustizia, che ha sperimentato lui stesso: la corte nella sua controversia con il cattolico si è schierata dalla parte di Osima, e non del suo correligionario. Il poeta arabo nota anche che i cristiani (in questo caso i Templari) gli diedero l'opportunità di pregare Allah nella propria cappella. In generale, gli autori islamici sottolineano che in materia di rito religioso i conquistatori furono piuttosto tolleranti: basti dire che nella cittadella crociata di Acri c'erano due moschee.
La popolazione ebraica del Levante era in una posizione simile a quella dei musulmani. Inoltre era loro proibito vivere a Gerusalemme e il carico fiscale era lo stesso. Tuttavia, vale la pena notare che sia i musulmani che gli ebrei non pagavano le decime ecclesiastiche, il che riduceva la pressione fiscale e talvolta causava malcontento tra alcune comunità cristiane; in particolare gli armeni di Gerusalemme lamentarono tale ingiustizia. E in generale, l'atteggiamento nei confronti degli ebrei negli stati cristiani dell'Est non era cattivo. Gli ebrei potevano praticare i loro riti religiosi abbastanza liberamente; nessuno li obbligava ad indossare abiti particolari indicanti la loro fede, che era costantemente praticata in Europa e spesso causava ostilità e persecuzioni. In Siria e Palestina per tutti i duecento anni non ci fu un solo pogrom contro gli ebrei. Non venne utilizzata nemmeno la pratica dei ghetti*, tanto amata in Europa: gli ebrei potevano stabilirsi liberamente nelle città e svolgere qualsiasi tipo di attività a loro discrezione.
Una revisione della situazione nazional-religiosa nell'Oriente latino sarà incompleta senza menzionare un altro gruppo molto interessante, il cosiddetto. Amante del Turkopo. Da loro furono reclutate unità ausiliarie di cavalleria leggermente armata di tipo selgiuchide. Da ciò è chiaro che i Turkopol erano discendenti dei Selgiuchidi e conservavano gli elementi fondamentali della loro vita e cultura. Tuttavia, l’origine dei Turcopoli non è ancora chiara. Forse questi erano turchi che si convertirono dall'Islam al cattolicesimo, sebbene tali transizioni siano un evento raro nella società di quel tempo. Potrebbero anche essere discendenti di matrimoni misti musulmano-cristiani: cristiani per fede e turchi per stile di vita. Infine potrebbero anche essere turchi musulmani che hanno attraversato II.-| lato del nemico e prestò giuramento di fedeltà ai crociati. La prima versione è forse supportata dal fatto che Saladino nel 1169 ordinò l'uccisione di tutti i turcopoli catturati. Un cambiamento di fede – cioè essenzialmente un tradimento dell'Islam – spiega pienamente questa rabbia del sovrano curdo, che in generale non era particolarmente assetato di sangue. E in tempi successivi ci furono precedenti di una transizione di massa dall'Islam al cristianesimo - basti ricordare i tartari battezzati al servizio dei granduchi russi.
I crociati conquistatori si unirono in modo abbastanza organico a questo conglomerato di popoli e culture. Già la seconda generazione dei “soldati di Cristo” differiva nettamente dai loro padri fanatici, così come dai pellegrini appena arrivati. E nonostante la costante guerra esterna condotta dagli stati cristiani (ad eccezione del suddetto mezzo secolo pacifico del 1193-1243), in essi fu stabilita una pace interna abbastanza forte. La storia dell'Oriente latino per tutti i due secoli della sua esistenza è quasi priva di grandi disordini popolari (di cui, tra l'altro, i vicini paesi musulmani non potevano vantarsi). Si stabilì una certa simbiosi: i Franchi garantivano la legge e l'ordine, i popoli conquistati, quasi senza cambiare il loro modo di vivere, pagavano tasse stabilite, non troppo onerose. Il famoso cronista Fulcher di Chartres parlò in modo figurato ed emotivo dell'attuale fenomeno culturale già nel 1120 (!): “Gente dell'Occidente, ci siamo trasformati in residenti dell'Est. L'italiano o il francese di ieri è diventato galileiano o palestinese. L'abitante di Reims o di Chartres era ora convertito in siriano o antiocheno. Abbiamo dimenticato il nostro paese natale. Qui si possiede la casa e la servitù con tale sicurezza, come se fosse un suo diritto ereditario da tempo immemorabile. Un altro prende per moglie una siriana, un'armena o anche una saracena battezzata. Il terzo vive con una famiglia locale, tutti parliamo diverse lingue di questa terra”.
La pace interna stabilita nell'Oriente latino portò presto ad una ripresa della vita economica. Gli stati crociati nei secoli XII-XIII erano in uno stato fiorente, nonostante la guerra costante e le incessanti incursioni della cavalleria regolare selgiuchide o dei ladri beduini. L'agricoltura del Levante ottenne un grande successo, avendo intrapreso la via della produzione di merci molto prima e con più fermezza dell'Europa.
I successi agricoli, ovviamente, furono facilitati dal fatto che sia la costa del Levante che molte terre nell'entroterra intorno al Mar di Galilea e lungo le rive del Giordano erano estremamente fertili e potevano coltivare diversi raccolti all'anno. .
Il clima eccellente, un sistema di irrigazione ben consolidato di canali e acquedotti preservato dall'epoca romana diedero ai contadini l'opportunità di coltivare un'ampia varietà di colture. Oltre al grano tradizionale venivano coltivati anche altri cereali, tra cui il miglio. La viticoltura, il giardinaggio e l'olivicoltura ricoprivano un ruolo molto importante nell'economia. Significativa era l'esportazione di questi beni verso l'Europa, dove l'olio d'oliva levantino e molte sue varietà erano molto apprezzati. I frutti mediterranei ec-yutici arrivarono anche sulle tavole dei nobili europei. È interessante notare che l'ormai famosa albicocca era un frutto completamente sconosciuto per l'Occidente e guadagnò popolarità solo dopo la conquista della Terra Santa. Inoltre, l'albicocca cominciò a godere della gloria del cibo “divino” e cominciò a essere coltivata attivamente nei monasteri, da dove si diffuse poi in tutta Europa.
L'agricoltura del Mediterraneo orientale fornì al mondo occidentale anche altri due prodotti estremamente importanti: lo zucchero e il cotone. Nel Levante, queste colture industriali venivano coltivate quasi esclusivamente per l'esportazione e, con la crescita dei rapporti merce-denaro, occuparono gradualmente un posto crescente nell'economia della regione. Infine, una voce di esportazione separata e importante erano le specie legnose pregiate, l'incenso e soprattutto le spezie, il cui commercio portò favolosi profitti e divenne uno dei principali fattori della prosperità economica del Levante nei secoli XII-XIII.
In generale, il commercio nei nuovi stati cristiani occupava un posto estremamente importante. Già dalla metà del XII secolo e soprattutto nella prima metà del XIII secolo il commercio, incentrato su grandi operazioni di import-export, divenne il motore trainante dell'intera economia levantina. Le città del Mediterraneo orientale, e soprattutto i porti, si trasformarono in fiorenti centri commerciali che attiravano mercanti da tutto il mondo. A metà del XIII secolo, Acri, che divenne la base di trasbordo più importante per il commercio di transito mondiale, ospitava più di sessantamila persone; era una delle città più grandi del mondo, superando in popolazione grandi capitali come Parigi, Roma e Londra. Acri, Tiro, Beirut, Tripoli e Laodicea divennero destinazioni di rotte commerciali da e per l'oriente, e divennero un luogo di incontro tra Oriente e Occidente.
La crescita del commercio levantino non poteva non attirare l'attenzione speciale di grandi città commerciali come Venezia, Genova e Pisa. Inizialmente il loro interesse si concentrava sul trasporto dei pellegrini, il cui numero aumentò notevolmente dopo la conquista di Gerusalemme, dei contingenti militari crociati e dell'equipaggiamento militare. Ciò portò ingenti entrate alle repubbliche cittadine italiane e divenne una delle principali fonti di accumulazione iniziale del capitale. A poco a poco, le priorità iniziarono a cambiare e all'inizio del XIII secolo, gli astuti mercanti italiani presero il controllo del commercio di transito di Leiantian. Nelle città costiere apparivano quartieri e interi quartieri appartenuti a mercanti genovesi o veneziani. A Tiro i veneziani, in generale, possedevano un terzo della città, sotto JTOM godevano del diritto di extraterritorialità e godevano di enormi benefici fiscali. Il quartiere genovese e Acri occupavano la piazza centrale con la chiesa ell. Lawrence e il palazzo dove si riuniva la camera del tribunale. Il quartiere aveva le proprie porte fortificate, i propri panifici, negozi e alberghi per i mercanti in visita.
Il commercio diede agli italiani dividendi colossali. Non era troppo raro ricevere un profitto del cinquecento o addirittura del mille per cento da una transazione commerciale. Ma anche tenendo conto di tutti i tipi di benefici fiscali (soprattutto perché, ad esempio, i mercanti bizantini o armeni non godevano di tali benefici), una quota considerevole di questo reddito rimaneva in Terra Santa, finendo nelle tasche di principi e feudatari. ; Alcune cose ricadevano anche sulla popolazione comune. Fu la portata senza precedenti delle operazioni commerciali a portare a una situazione unica per il Medioevo, quando i feudi spesso non prevedevano proprietà terriere, ma vari pagamenti finanziari: quote di tasse o tasse portuali, interessi sulle transazioni commerciali, ecc. In condizioni di instabilità Il possesso feudale delle terre - ci si poteva sempre aspettare un'invasione musulmana - era una sorta di assicurazione per signori e cavalieri, che permetteva loro di investire nel rafforzamento dei loro castelli. E sebbene la nobiltà feudale non partecipasse direttamente alle operazioni commerciali - ciò contraddiceva il codice d'onore cavalleresco non scritto - la sua stessa ricchezza e persino, in una certa misura, il potere politico erano basati proprio sul successo del commercio.
I vantaggi economici dell'élite principesco-cavaliere erano ben supportati da carte vincenti legali. Nella seconda metà del XII secolo, sotto il re Amalrico, fu finalmente formulata e scritta una serie di leggi: le famose Assise di Gerusalemme. Purtroppo questo meraviglioso monumento del diritto medievale non è giunto fino a noi: i manoscritti con la documentazione completa delle leggi andarono perduti durante la conquista di Gerusalemme da parte di Saladino. Ma fino alla caduta di Acri prevalse la tradizione orale di interpretazione di queste leggi; C'erano anche commenti scritti, di cui il più famoso era il cosiddetto. "Il Libro di Jean d'Ibelin." Il suo autore stesso era un rappresentante dell'élite principesca, il conte di Giaffa, e nella sua opera sia gli aspetti politici che le procedure legali legate ai concetti di vassallaggio e proprietà feudale, le regole di condotta dei cavalieri e i limiti della giurisdizione sono stati analizzati con particolare dettaglio in relazione ai feudatari.
Anche sulla base delle fonti che ci sono pervenute possiamo tranquillamente affermare che le assise di Gerusalemme costituivano davvero un corpo fondamentale del diritto feudale. Del resto le assise difendevano, per così dire, il “feudalesimo al quadrato”, il feudalesimo nelle sue forme più vive e pure. Definevano molto chiaramente i rapporti di vassallaggio e limitavano rigorosamente i poteri del governo centrale rispetto ai baroni al potere. In effetti, i grandi proprietari terrieri nei loro possedimenti erano quasi sovrani sovrani, tenendo nelle loro mani sia la vita che le proprietà dei loro sudditi. Qualsiasi signore feudale poteva essere condannato solo da un tribunale di pari, cioè signori di rango uguale a lui: le possibilità legislative e politiche dei re erano nettamente limitate e si riducevano effettivamente all'accettazione formale del giuramento di fedeltà - omaggio. Tuttavia, nel XII secolo, un secolo di guerre permanenti, i re avevano ancora una notevole autorità in quanto detentori del potere supremo. Con l'avvento di un'era relativamente pacifica, il potere reale dei re cominciò a diminuire rapidamente; sono diventati effettivamente niente più che “primi tra pari”. Alla fine, il titolo stesso di Re di Gerusalemme si trasformò semplicemente in una carta da giocare, regalando al vincitore della partita quasi null'altro che soddisfazione morale. E se in Europa il XIII secolo divenne il secolo della formazione di stati centralizzati e della limitazione dell'arbitrarietà di principi e signori, allora in Palestina questi anni furono il tempo della conservazione degli ordini feudali più odiosi.
Tuttavia, questa frammentazione politica ebbe scarsi effetti sulla vita economica degli stati del Levante, per i quali la prima metà del XIII secolo fu il periodo di massima prosperità economica. Pertanto, la sola Acri nel 1240 produceva circa cinquantamila libbre d'argento all'anno sotto forma di tasse e tasse (esclusi i profitti effettivi delle operazioni commerciali), che superavano le entrate finanziarie del re d'Inghilterra. A Tripoli nel XIII secolo c'erano quattromila telai per la tessitura della seta, e Antiochia non era inferiore ad essa. Nei mercati di Tiro e Acri si potevano acquistare merci provenienti da tutto il mondo: stoffe e tessuti europei, spezie arabe e indiane, nobili cavalli dell'Asia centrale. Fino a quando i Mongoli non tagliarono la Grande Via della Seta a metà del XIII secolo, le carovane arrivavano nel Levante addirittura dalla Cina.
Gli ingenti guadagni apportati dal commercio levantino, in particolare dal commercio delle spezie, hanno permesso di investire ingenti fondi nella costruzione e nel miglioramento del tenore di vita. La conoscenza dei crociati con la cultura islamica altamente sviluppata introdusse molte delle sue conquiste nell'uso cristiano. Una di queste conquiste fu il grande successo delle procedure igieniche, a quel tempo quasi sconosciute in Europa. C'erano dozzine di stabilimenti balneari nelle città, alcuni potevano ospitare fino a mille persone. L'uso dei cosmetici è diventato di moda tra le donne; Sorsero anche qualcosa come i saloni di bellezza, dove le donne potevano socializzare e prestare attenzione al proprio aspetto. In numerosi ospedali degli ordini Giovanniti e Teutonici, non solo i pellegrini, ma anche i poveri delle città potevano ricevere un'ampia varietà di cibo e cure mediche. Nelle case dei nobili e dei grandi mercanti, piscine e fontane erano all'ordine del giorno.
Eppure, nonostante una certa compenetrazione tra le culture cristiana e musulmana, il suo grado non dovrebbe essere esagerato. I “soldati di Cristo” non si fusero affatto con la popolazione conquistata; Ogni gruppo nazionale e religioso viveva separatamente, essenzialmente ripiegandosi su se stesso. Un nobile poteva conoscere diverse lingue del paese per facilitare la comunicazione, ma, ad esempio, durante tutti i due secoli di dominio cristiano, non fu tradotto in latino un solo libro arabo, comunemente usato dai cattolici. Tuttavia, allo stesso modo, i musulmani accettarono la cultura occidentale introdotta. L'Oriente latino era un conglomerato di culture assolutamente straordinario, ciascuna delle quali manteneva la propria identità.
Contenuto:
1.Introduzione………………………………3
2. Luminosità e intensità della vita……………..…………….4
3. Cavalleria…………………..7
4. Il significato della cattedrale in una città medievale……………10
5. Abitante della città e tempo……………..………..14
6.La criminalità del Medioevo……………………………..16
7. Il ruolo della Chiesa………………
7.1 Il ruolo della Chiesa nell'educazione……………..18
8. Conclusione..................................................................19
Appendice…………………………...……...20
Elenco dei riferimenti……………………..21
1. Introduzione
. Volevo dare uno sguardo più da vicino alla vita in quei tempi. Come vivevano le persone? Qual era la loro moralità? Da cosa sei stato guidato nella vita? Quali preoccupazioni quotidiane occupavano le loro menti? Quanto contrastano gli interessi delle persone di oggi e di quelli di allora? Proprio come adesso c'erano le grandi città e le piazze, ma da allora molto è cambiato: se prima in piazza si sentiva
lo scricchiolio delle ruote, il clangore degli zoccoli, il battito degli zoccoli di legno, le grida dei venditori ambulanti, il ruggito e il tintinnio delle officine artigianali, ma ora questo è stato sostituito dal ritmo frenetico delle strade cittadine e degli stabilimenti industriali. Come sono cambiate le persone?
Ero interessato a scoprire quale ruolo avesse la cattedrale. E perché così tanto tempo è stato dedicato alla costruzione della cattedrale. Che significato ha dato la cattedrale alla vita pubblica?
2. Luminosità e intensità della vita
Quando il mondo era cinque secoli più giovane, tutti gli eventi della vita assumevano forme molto più nettamente definite rispetto ai nostri tempi. La sofferenza e la gioia, la sfortuna e la buona sorte sono molto più palpabili; le esperienze umane hanno mantenuto il grado di completezza e spontaneità con cui l'anima di un bambino percepisce fino ad oggi il dolore e la gioia. Ogni azione, ogni atto seguiva un rituale sviluppato ed espressivo, elevandosi a uno stile di vita duraturo e immutabile. Eventi importanti: nascita, matrimonio, morte - grazie ai sacramenti della chiesa, hanno raggiunto lo splendore di un mistero. Anche le cose non così significative, come viaggi, lavoro, affari o visite amichevoli, erano accompagnate da ripetute benedizioni, cerimonie, detti e venivano fornite con determinati rituali.
Non c'era modo di aspettarsi sollievo dalle disgrazie e dalle privazioni; a quel tempo erano molto più dolorose e terribili. La malattia e la salute erano molto più diverse, l'oscurità spaventosa e il freddo intenso in inverno erano un vero male. Godevano della nobiltà e della ricchezza con maggiore avidità e più seriamente, poiché si opponevano alla povertà evidente e al rifiuto molto più duramente. Un mantello foderato di pelliccia, un fuoco caldo dal focolare, vino e uno scherzo, un letto morbido e confortevole portarono quell'enorme piacere, che in seguito, forse grazie ai romanzi inglesi, divenne invariabilmente l'incarnazione più vivida delle gioie quotidiane. Tutti gli aspetti della vita venivano mostrati con arroganza e rudezza. I lebbrosi facevano roteare i sonagli e si radunavano in cortei, i mendicanti urlavano sotto i portici, mettendo a nudo il loro squallore e le loro deformità. Condizioni e classi, gradi e professioni si distinguevano per l'abbigliamento. I nobili gentiluomini si muovevano risplendenti nello splendore delle loro armi e dei loro abiti, con timore e invidia di tutti. L'amministrazione della giustizia, la comparsa di mercanti con beni, matrimoni e funerali venivano annunciati a gran voce con grida, cortei, pianti e musica. Gli amanti indossavano i colori della loro dama, i membri della confraternita indossavano il loro emblema e i sostenitori di una persona influente indossavano distintivi e insegne corrispondenti.
Anche l'aspetto delle città e dei villaggi era dominato dalla diversità e dai contrasti. La città medievale non si fondeva, come le nostre città, in squallide periferie con case semplici e fabbriche noiose, ma agiva come un tutt'uno, circondato da mura e irto di formidabili torri. Non importa quanto alte e massicce fossero le case di pietra dei mercanti o dei nobili, gli edifici del tempio con la loro mole regnavano maestosamente sulla città.
La differenza tra estate e inverno si sentiva più nettamente che nella nostra vita, così come tra luce e oscurità, silenzio e rumore. La città moderna difficilmente conosce l'oscurità impenetrabile, il silenzio mortale, l'impatto impressionante di una sola luce o di un solo grido lontano.
A causa dei continui contrasti, della diversità delle forme di tutto ciò che toccava la mente e i sentimenti, la vita quotidiana eccitava e infiammava le passioni, che si manifestavano o in esplosioni inaspettate di cruda sfrenatezza e brutale crudeltà, o in esplosioni di reattività spirituale, nel mutevole atmosfera di cui scorreva la vita della città medievale.
Ma un suono invariabilmente soffocava il rumore della vita irrequieta; per quanto vario fosse, non si mescolava con nulla e sollevava tutto ciò che era superiore nella sfera dell'ordine e della chiarezza. Questo suono di campane nella vita di tutti i giorni era paragonato all'avvertimento degli spiriti buoni che, con voci familiari, annunciavano dolore e gioia, pace e ansia, convocavano il popolo e avvertivano del pericolo imminente. Erano chiamati per nome: Roland, Fat Woman, Jacqueline - e ognuno capiva il significato di questo o quello squillo. E sebbene le campane suonassero quasi incessantemente, l'attenzione al loro suono non si attenuava. Nella continuazione del famigerato duello giudiziario tra due cittadini nel 1455, che gettò sia la città che l'intera corte borgognona in uno stato di incredibile tensione, una grande campana - "una cosa terrificante da sentire", secondo Chatellain - suonò fino al la lotta era finita. Sulle chiese campanarie di Nostra Signora di Anversa è ancora appesa un'antica campana d'allarme, fusa nel 1316 e soprannominata "Orida", cioè "Orida". horrida: spaventoso. Quale incredibile emozione deve aver colto tutti quando tutte le chiese e i monasteri di Parigi hanno suonato le campane dalla mattina alla sera - e anche di notte - in occasione dell'elezione di un papa che avrebbe dovuto porre fine allo scisma, o in onore della conclusione della pace tra i Bourguignon e gli Armagnac.
Le processioni erano senza dubbio uno spettacolo profondamente commovente. Nei momenti difficili – e accadevano spesso – i cortei si sostituivano, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Quando la disastrosa faida tra le Casate d'Orleans e le Casate di Borgogna portò infine ad una guerra civile aperta, il re Carlo VI nel 1412 dispiegò l'orifiamma per opporsi, insieme a Giovanni l'Impavido, agli Armagnac, che tradirono la loro patria stringendo un'alleanza con gli inglesi; a Parigi, durante la permanenza del re in terre ostili, si decise di organizzare processioni quotidiane. Durarono dalla fine di maggio fin quasi alla fine di luglio; vi parteciparono successivi ordini, corporazioni e corporazioni; Ogni volta camminavano lungo strade diverse e ogni volta portavano reliquie diverse. In questi giorni la gente digiunava; tutti camminavano a piedi nudi: i consiglieri parlamentari e i cittadini più poveri. Molti portavano torce o candele. C'erano sempre bambini tra i partecipanti al corteo. I contadini poveri venivano a Parigi a piedi, da lontano, scalzi. La gente camminava o guardava quelli che camminavano. Ed è stato un periodo molto piovoso.
E poi c'erano gli ingressi cerimoniali di nobili brillanti, disposti con tutta l'astuzia e l'abilità di cui la fantasia era capace. E in infinita abbondanza: esecuzioni. L'eccitazione crudele e la cruda simpatia evocate dallo spettacolo del patibolo erano una parte importante del cibo spirituale del popolo. Queste sono esibizioni con insegnamento morale. Si inventano punizioni orribili per crimini terribili. A Bruxelles, un giovane piromane e assassino è incatenato a un anello posto su un palo, attorno al quale bruciano fasci di sterpaglie e paglia. Rivolgendosi al pubblico con parole toccanti, ha addolcito i loro cuori così tanto "che hanno versato tutte le lacrime per compassione e hanno dato alla sua morte un esempio come il più bello che qualcuno avesse mai visto". Mensir Mansart du Bois, un Armagnac che sarà decapitato nel 1411. a Parigi, durante il terrore borgognone, non solo concede con tutto il cuore il perdono al boia, che chiede secondo l'usanza, ma vuole anche scambiare con lui un bacio. "E c'erano folle di persone lì, e tutti stavano quasi piangendo lacrime amare." Spesso i condannati erano nobili gentiluomini, e quindi il popolo riceveva dall'esecuzione di una giustizia inesorabile una soddisfazione ancora più vivida e una lezione ancora più crudele sulla fragilità della grandezza terrena di quanto qualsiasi rappresentazione pittorica della Danza della Morte potesse fornire. Le autorità hanno cercato di non perdere nulla per ottenere l'effetto dell'intera rappresentazione: segni dell'alta dignità dei condannati li hanno accompagnati durante questo lugubre corteo.
La vita quotidiana dava invariabilmente libertà infinita alle passioni ardenti e all'immaginazione dei bambini. La moderna scienza del Medioevo, che a causa dell'inattendibilità delle cronache si rivolge, per quanto possibile, prevalentemente a fonti di carattere ufficiale, cade così inconsapevolmente in un pericoloso errore. Tali fonti non evidenziano sufficientemente le differenze di stile di vita che ci separano dal Medioevo. Ci fanno dimenticare l'intenso pathos della vita medievale. Di tutte le passioni che lo coloravano, ce ne parlano solo due: l'avidità e la belligeranza. Chi non rimarrebbe stupito dalla furia e dalla costanza quasi incomprensibili con cui l'interesse personale, la litigiosità e la vendetta vengono alla ribalta nei documenti legali del tardo Medioevo! Solo in connessione con questa passione che ha travolto tutti, bruciando tutti gli aspetti della vita, si possono comprendere e accettare le aspirazioni caratteristiche di quelle persone. Ecco perché le cronache, anche se sfiorano la superficie degli eventi descritti e spesso forniscono anche informazioni false, sono assolutamente necessarie se vogliamo vedere questo momento nella sua vera luce.
La vita conservava ancora il sapore di una fiaba. Se anche cronisti di corte, nobili, dotti, stretti collaboratori dei sovrani, vedessero e raffigurassero quest'ultimo nient'altro che in una forma arcaica, ieratica, allora cosa dovrebbe significare il magico splendore del potere reale per l'ingenua fantasia popolare!
Comunità di cittadini. L'unicità delle città medievali dell'Europa occidentale era data dal loro sistema socio-politico. Tutte le altre caratteristiche - concentrazione della popolazione, strade strette, mura e torri, occupazioni dei cittadini, funzioni economiche e ideologiche e ruolo politico - potrebbero essere inerenti anche a città di altre regioni e altre epoche. Ma solo nell'Occidente medievale la città si presenta invariabilmente come una comunità autoregolamentata, dotata di un grado di autonomia relativamente elevato e in possesso di diritti speciali e di una struttura abbastanza complessa.
3.Cavalleria
La cavalleria è uno strato sociale privilegiato speciale della società medievale. Tradizionalmente, questo concetto è associato alla storia dei paesi dell'Europa occidentale e centrale, dove, durante il periodo di massimo splendore del Medioevo, essenzialmente tutti i guerrieri feudali secolari appartenevano al cavalierato. Ma più spesso questo termine viene usato in relazione ai signori feudali medi e piccoli in contrapposizione alla nobiltà. L'origine del cavalierato risale al periodo dell'alto medioevo (VII-VIII secolo), quando si diffusero forme condizionate di possesso fondiario feudale, prima permanente, poi ereditario. Nel trasferire la terra a un feudo, il concedente diventava un signore (suzerain), e il beneficiario diventava un vassallo di quest'ultimo, il che implicava il servizio militare (il servizio militare obbligatorio non superava i 40 giorni all'anno) e l'adempimento di alcuni altri compiti in favore del signore. Questi includevano un "aiuto" monetario nel caso in cui un figlio venisse nominato cavaliere, il matrimonio di una figlia o la necessità di riscattare un signore che era stato catturato. Secondo la consuetudine, i vassalli partecipavano alla corte del signore ed erano presenti al suo consiglio. La cerimonia di formalizzazione dei rapporti vassalli era chiamata omaggio e il giuramento di fedeltà al signore era chiamato foie. Se l'estensione delle terre ricevute per il servizio lo consentiva, il nuovo proprietario, a sua volta, ne cedeva parte in feudi ai suoi vassalli (subfeudazione). È così che ha preso forma un sistema di vassallaggio in più fasi ("sovranità", "gerarchia feudale", "scala feudale") dal signore supremo - il re ai cavalieri con scudo singolo che non avevano i propri vassalli. Per i paesi continentali dell'Europa occidentale, le regole delle relazioni vassalli riflettevano il principio: "il vassallo del mio vassallo non è il mio vassallo", mentre, ad esempio, in Inghilterra (giuramento di Salisbury del 1085) la dipendenza vassallo diretta di tutti i proprietari terrieri feudali dal il re fu introdotto con il servizio obbligatorio nell'esercito reale.
La gerarchia dei rapporti vassalli ripeteva la gerarchia delle proprietà terriere e determinava il principio della formazione della milizia militare dei feudatari. Pertanto, insieme all'instaurazione di rapporti militare-feudali, ebbe luogo la formazione del cavalierato come classe militare-feudale al servizio, che fiorì nei secoli XI-XIV. Gli affari militari divennero la sua principale funzione sociale. La professione militare conferiva diritti e privilegi, determinava particolari visioni di classe, standard etici, tradizioni e valori culturali.
I doveri militari dei cavalieri includevano la protezione dell'onore e della dignità del signore supremo e, soprattutto, la terra dall'invasione sia dei vicini sovrani feudali nelle guerre intestine, sia delle truppe di altri stati in caso di attacco esterno. In condizioni di guerra civile, il confine tra la protezione dei propri beni e l'impossessamento delle terre altrui era piuttosto labile, e un paladino della giustizia a parole spesso si rivelava un invasore nella pratica, per non parlare della partecipazione alle campagne di conquista organizzate dal re. autorità, come le numerose campagne degli imperatori tedeschi in Italia, o dallo stesso Papa, come le Crociate. L'esercito cavalleresco era una forza potente. Le sue armi e le sue tattiche di battaglia corrispondevano ai compiti militari, alla portata delle operazioni militari e al livello tecnico del suo tempo. Protetto da armature militari in metallo, la cavalleria cavalleresca, poco vulnerabile ai fanti e alle milizie contadine, ha svolto il ruolo principale in battaglia.
Le guerre feudali non esaurirono il ruolo sociale della cavalleria. In condizioni di frammentazione feudale e di relativa debolezza del potere regio, la cavalleria, vincolata da un sistema di vassallaggio in un’unica corporazione privilegiata, proteggeva la proprietà fondiaria dei feudatari, base del loro dominio. Un esempio lampante di ciò è la storia della repressione della più grande rivolta contadina in Francia: la Jacquerie (1358-1359), scoppiata durante la Guerra dei Cent'anni. Allo stesso tempo, i cavalieri che rappresentavano le parti in guerra, inglesi e francesi, si unirono sotto gli stendardi del re navarrese Carlo il Malvagio e rivoltarono le loro armi contro i contadini ribelli, risolvendo un problema sociale comune. La cavalleria influenzò anche i processi politici dell'epoca, poiché gli interessi sociali della classe feudale nel suo insieme e le norme della moralità cavalleresca in una certa misura frenarono le tendenze centrifughe e limitarono i liberi feudali. Durante il processo di centralizzazione dello stato, i cavalieri (medi e piccoli signori feudali) costituirono la principale forza militare dei re nella loro opposizione alla nobiltà nella lotta per l'unificazione territoriale del paese e il potere reale nello stato. Questo fu, ad esempio, il caso della Francia del XIV secolo, quando, in violazione della precedente norma del diritto vassallo, una parte significativa dei cavalieri fu reclutata nell'esercito del re sulla base di un pagamento in denaro.
La partecipazione all'esercito cavalleresco richiedeva un certo livello di sicurezza e la concessione della terra non era solo una ricompensa per il servizio, ma anche una condizione materiale necessaria per la sua attuazione, poiché il cavaliere acquisiva sia un cavallo da guerra che costose armi pesanti (lancia, spada , mazza, armatura, armatura per il cavallo) a proprie spese, per non parlare del mantenimento del seguito corrispondente. L'armatura cavalleresca comprendeva fino a 200 parti e il peso totale dell'equipaggiamento militare raggiungeva i 50 kg; Nel tempo, la loro complessità e il loro prezzo sono aumentati. Il sistema di addestramento e istruzione cavalleresco serviva a preparare i futuri guerrieri. Nell'Europa occidentale, i ragazzi fino all'età di 7 anni crescevano in una famiglia; successivamente, fino all'età di 14 anni, venivano allevati alla corte di un signore come paggio, poi come scudiero, e infine si teneva una cerimonia farli cavalieri.
La tradizione richiedeva che il cavaliere fosse esperto in materia religiosa, conoscesse le regole dell'etichetta di corte e padroneggiasse le "sette virtù cavalleresche": equitazione, scherma, abile maneggio della lancia, nuoto, caccia, gioco di dama, scrittura e canto di poesie in onore della signora del cuore.
Il titolo di cavaliere simboleggiava l'ingresso in una classe privilegiata, la familiarità con i suoi diritti e responsabilità ed era accompagnato da una cerimonia speciale. Secondo l'usanza europea, il cavaliere che iniziava il grado colpiva l'iniziatore sulla spalla con il piatto della spada, pronunciava la formula di iniziazione, indossava un elmo e speroni d'oro, presentava una spada - simbolo della dignità cavalleresca - e uno scudo con l'immagine di uno stemma e di un motto. L'iniziato, a sua volta, prestava giuramento di fedeltà e si impegnava a sostenere un codice d'onore. Il rituale spesso terminava con un torneo cavalleresco (duello): una dimostrazione di abilità e coraggio militare.
Tradizioni cavalleresche e standard etici speciali si sono sviluppati nel corso dei secoli. Il codice d'onore si basava sul principio di lealtà al signore supremo e al dovere. Le virtù cavalleresche includevano il coraggio militare e il disprezzo per il pericolo, l'orgoglio, un atteggiamento nobile nei confronti delle donne e l'attenzione ai membri delle famiglie cavalleresche bisognose di aiuto. L'avarizia e l'avarizia furono condannate e il tradimento non fu perdonato.
Ma l’ideale non sempre corrispondeva alla realtà. Per quanto riguarda le campagne predatorie in terre straniere (ad esempio, la cattura di Gerusalemme o Costantinopoli durante le Crociate), le “gesta” cavalleresche portarono dolore, rovina, rimprovero e vergogna non solo alla gente comune.
Le Crociate contribuirono alla formazione di idee, costumi, moralità cavalleresca e all'interazione delle tradizioni occidentali e orientali. Durante il loro corso, in Palestina sorsero organizzazioni speciali di signori feudali dell'Europa occidentale per proteggere ed espandere i possedimenti dei crociati: ordini cavallereschi spirituali. Questi includono l'Ordine Giovannita (1113), l'Ordine Templare (1118) e l'Ordine Teutonico (1128). Successivamente operarono in Spagna gli ordini di Calatrava, Sant Iago e Alcantara. L'Ordine della Spada e del Livoniano è conosciuto nei Paesi Baltici. I membri dell'ordine prendevano voti monastici (non cupidigia, rinuncia alla proprietà, castità, obbedienza), indossavano abiti simili a quelli monastici e sotto di essi - armature militari. Ogni ordine aveva un proprio abbigliamento distintivo (i Templari, ad esempio, avevano un mantello bianco con una croce rossa). Dal punto di vista organizzativo, furono costruiti sulla base di una rigida gerarchia, guidata da un maestro eletto e approvato dal Papa. Sotto il maestro vi era un capitolo (consiglio) con funzioni legislative.
La riflessione della morale cavalleresca nel campo della cultura spirituale ha aperto la pagina più luminosa letteratura medievale con il suo sapore, genere e stile speciali. Ha poeticizzato le gioie terrene nonostante l'ascetismo cristiano, ha glorificato l'eroismo e non solo ha incarnato gli ideali cavallereschi, ma li ha anche modellati. Insieme all'epica eroica dal suono altamente patriottico (ad esempio, la "Canzone di Roland" francese, la "Canzone del mio Cid" spagnola), apparve la poesia cavalleresca (ad esempio, i testi dei trovatori e dei trovatori in Francia e dei Minnesinger in Germania) e un romanzo cavalleresco (la storia d'amore di Tristano e Isotta), che rappresenta la cosiddetta “letteratura cortese” (dal francese courtois - cortese, cavalleresco) con il culto obbligatorio della dama.
In Europa, la cavalleria ha perso la sua importanza come principale forza militare degli stati feudali a partire dal XV secolo. Il presagio del declino della gloria della cavalleria francese fu la cosiddetta "Battaglia degli Speroni" (11 luglio 1302), quando la milizia a piedi dei cittadini fiamminghi sconfisse la cavalleria cavalleresca francese. Successivamente, l'inefficacia delle azioni dell'esercito cavalleresco francese fu chiaramente evidente nella prima fase della Guerra dei Cent'anni, quando subì una serie di gravi sconfitte da parte dell'esercito inglese. La cavalleria si rivelò incapace di resistere alla concorrenza degli eserciti mercenari che usavano armi da fuoco (apparvero nel XV secolo). Le nuove condizioni dell'era della decomposizione del feudalesimo e l'emergere delle relazioni capitaliste portarono alla sua scomparsa dall'arena storica. Nei secoli XVI-XVII. il cavalierato perde finalmente la specificità di classe speciale e diventa parte della nobiltà.
Rappresentanti delle antiche famiglie cavalleresche, cresciuti nelle tradizioni militari dei loro antenati, formarono il corpo degli ufficiali degli eserciti dell'era assolutista, intrapresero rischiose spedizioni marittime e realizzarono conquiste coloniali. La nobile etica dei secoli successivi, compresi i nobili principi di fedeltà al dovere e degno servizio alla patria, porta senza dubbio l'influenza dell'era cavalleresca.
4. Il significato della cattedrale in una città medievale
Nella città medievale la cattedrale fu per lungo tempo l'unico edificio pubblico. Ha svolto il ruolo non solo di centro religioso, ideologico, culturale, educativo, ma anche amministrativo e, in una certa misura, economico. Più tardi apparvero i municipi e i mercati coperti, ai quali passarono alcune funzioni della cattedrale, ma anche allora essa non rimase affatto solo un centro religioso. L'idea che “gli obiettivi principali della città... servivano come base materiale e simboli delle forze sociali contrastanti che dominavano la vita urbana: il sostegno del castello al potere feudale secolare; la cattedrale è l'incarnazione del potere del clero; Il municipio è una roccaforte dell’autogoverno dei cittadini” (A.V. Ikonnikov) – è vero solo in parte. La loro accettazione incondizionata semplifica la vita socio-culturale della città medievale.
È abbastanza difficile per una persona moderna percepire la varietà di funzioni di una cattedrale medievale e il suo significato in tutte le sfere della vita cittadina. La cattedrale rimase un tempio, un edificio religioso, oppure divenne un monumento architettonico e culturale, un museo, una sala da concerto, necessaria e accessibile a pochi. La sua vita oggi non trasmette la pienezza della sua esistenza nel passato.
La città medievale era piccola e racchiusa da mura. I residenti lo hanno percepito in modo olistico, come un insieme, un sentimento perduto nella città moderna. La cattedrale definisce il centro architettonico e spaziale della città; con qualsiasi tipo di pianificazione urbanistica, il reticolo di strade gravitava verso di essa. Essendo l'edificio più alto della città, fungeva da torre di guardia, se necessario. La piazza della Cattedrale era la principale, e talvolta l'unica. Tutti gli eventi pubblici vitali si sono svolti o hanno avuto inizio in questa piazza. Successivamente, quando il mercato fu spostato dalla periferia alla città e apparve una speciale piazza del mercato, uno dei suoi angoli è spesso adiacente alla cattedrale. Ciò è accaduto in diverse città della Germania e della Francia: Dresda, Meissen, Naumburg, Montauban, Monpazier. In città, oltre alla cattedrale principale, di regola c'erano anche le chiese parrocchiali, e ad esse venivano trasferite alcune delle funzioni della cattedrale. Nelle grandi città il loro numero potrebbe essere significativo. Quindi una nota contemporanea a Londra alla fine del XII secolo. Centoventisei chiese di questo tipo.
La cattedrale appare ai nostri occhi ammirati in forma compiuta e “purificata”. Intorno ad esso non ci sono quelle piccole botteghe e panchine che, come nidi di uccelli, si aggrappavano a tutte le sporgenze e provocavano la richiesta da parte delle autorità cittadine e ecclesiastiche di “non fare buchi nei muri del tempio”. L'inadeguatezza estetica di questi negozi, a quanto pare, non ha disturbato affatto i contemporanei, sono diventati parte integrante della cattedrale e non hanno interferito con la sua grandezza. Anche la sagoma della cattedrale era diversa, poiché l'una o l'altra delle sue ali era costantemente situata nelle foreste.
La città medievale era rumorosa: in un piccolo spazio si sentiva lo scricchiolio delle ruote, il clangore degli zoccoli, il battito degli zoccoli di legno, le grida dei venditori ambulanti, il ruggito e il tintinnio delle botteghe artigiane, le voci e i campanacci degli animali domestici, che furono cacciati dalle strade solo gradualmente dalle autorità cittadine, e dai rantoli dei malati di lebbra. “Ma un suono invariabilmente soffocava il rumore di una vita inquieta: non importa quanto fosse vario, non si mescolava con nulla, elevando tutto ciò che accadeva nella sfera dell'ordine e della chiarezza. Questa è una campana che suona. Nella vita di tutti i giorni le campane erano paragonate all'avvertimento degli spiriti buoni che, con voci familiari a tutti, annunciavano dolore e gioia, pace e ansia, chiamavano la gente e avvertivano del pericolo imminente. Erano chiamati per nome: Roland, Fat Woman-Jacqueline - e tutti capivano il significato di questo o quello squillo. E sebbene le loro glosse risuonassero quasi incessantemente, l'attenzione al loro suono non era affatto offuscata” (J. Huizinga). La spighetta della cattedrale ha fornito a tutti i cittadini le informazioni necessarie contemporaneamente: su un incendio, sul mare, su un attacco o su qualsiasi evento di emergenza all'interno della città. E oggi gli antichi “Big Pol” o “Big Ben” animano lo spazio di una città moderna.
La cattedrale era la custode del tempo. Le campane scandivano le ore del servizio mattutino, ma per molto tempo annunciarono anche l’inizio e la fine del lavoro dell’artigiano. Fino al XIV secolo. - l'inizio della diffusione degli orologi meccanici da torre - era la campana della cattedrale a scandire il ritmo di una “vita ben ordinata”.
L'occhio vigile della chiesa accompagnava il cittadino dalla nascita alla morte. La chiesa lo accettò nella società e lo aiutò anche a trasferirsi nell'aldilà. I sacramenti e i rituali della Chiesa erano una parte essenziale della vita quotidiana. Battesimo, fidanzamento, cerimonia nuziale, servizio funebre e sepoltura, confessione e comunione: tutto ciò collegava l'abitante della città con la cattedrale o la chiesa parrocchiale (nelle piccole città la cattedrale era anche la chiesa parrocchiale), permettendogli di sentirsi parte della comunità cristiana società. La cattedrale fungeva anche da luogo di sepoltura per i cittadini facoltosi; alcuni avevano tombe di famiglia chiuse lì con lapidi. Ciò non era solo prestigioso, ma anche pratico (come notano gli storici, si verificavano costantemente rapine ai cimiteri parrocchiali).
Il rapporto tra i cittadini e il clero cittadino era tutt'altro che idilliaco. Le cronache di Guiberto di Nogent, Ottone di Freisingen, Richard Devize non dicono nulla di buono sugli abitanti della città. A sua volta, nella letteratura urbana - fabliau, schwanks, poesia satirica - il monaco e il prete vengono spesso ridicolizzati. I cittadini si oppongono alla libertà del clero dalle tasse; cercano non solo di liberarsi dal potere dei loro prelati signori, ma anche di sottomettere al controllo municipale gli affari che tradizionalmente erano sotto la giurisdizione della chiesa. Indicativa al riguardo è l'evoluzione della situazione degli ospedali, che nel corso dei secoli XIII-XIV. cessano gradualmente di essere istituzioni ecclesiastiche, pur conservando il patronato della chiesa e, quindi, l'inviolabilità dei loro beni. Tuttavia, la frequente opposizione al clero si combina con i costanti contatti con loro nella vita di tutti i giorni e non impedisce ai cittadini di considerare la costruzione e la decorazione della cattedrale la loro opera vitale.
Alla costruzione della cattedrale della città hanno preso parte non solo i cittadini, ma anche i contadini, i magnati e il clero circostanti. Le cronache medievali e altri documenti riflettevano esempi di entusiasmo religioso che stupirono i contemporanei: "donne, cavalieri, tutti cercarono non solo di donare, ma anche di aiutare la costruzione con tutta la manodopera possibile". Spesso venivano raccolti fondi in tutto il Paese per la costruzione della cattedrale. “Nel Medioevo si diffusero un'ampia varietà di donazioni, donazioni e contributi per la costruzione di un tempio, considerati un atto degno e benefico. Molto spesso si trattava di donazioni di gioielli e oggetti di valore, somme di denaro o fornitura gratuita di materiali per la costruzione futura” (K.M. Muratov). La costruzione della cattedrale richiese diversi decenni, ma il completamento completo dell'edificio richiese secoli. Di generazione in generazione, furono raccontate leggende sulla fondazione e la costruzione del tempio, furono raccolti sempre più fondi, furono fatte donazioni e lasciati testamenti. La frase del legato pontificio ed ex rettore dell'Università di Parigi, Odo de Chateauroux, secondo cui "la cattedrale di Notre Dame è stata costruita con i soldi delle povere vedove", ovviamente, non dovrebbe essere presa alla lettera, ma ci sono delle ragioni dietro. Un sincero impulso di pietà si univa alla rivalità con la città vicina e, per alcuni, al desiderio di ricevere l'assoluzione personale. La bellissima cattedrale era uno degli importanti segni di prestigio, a dimostrazione della forza e della ricchezza della comunità cittadina. Le dimensioni dei templi costruiti in città molto piccole, il lusso e la complessità dei loro interni soddisfano la necessità di creare qualcosa di incommensurabile in bellezza e grandezza con tutto ciò che lo circonda. L'importanza della cattedrale è testimoniata anche dalla volontà di restaurarla subito dopo l'incendio, e sicuramente nello stesso luogo, per preservare i consueti oggetti di pellegrinaggio.
La costruzione della cattedrale fu per molti anni al centro dell'attenzione dei cittadini, ma entrò in funzione molto prima del suo completamento definitivo. La costruzione iniziò con la parte del coro; il tetto veniva solitamente costruito anche prima che il tempio fosse coperto con le volte, in modo che il culto potesse essere celebrato abbastanza rapidamente dopo l'inizio della costruzione.
La costruzione e la decorazione del tempio servirono da impulso allo sviluppo della città mestiere artistico. Il famoso “Libro dei mestieri” parigino (XIII secolo) riporta alcune di queste professioni, il cui utilizzo nella vita quotidiana della città sarebbe molto limitato. Tra loro ci sono pittori, intagliatori di pietre, fabbricanti di filigrana, scultori, fabbricanti di rosari (di corallo, conchiglie, osso, corno, ambra grigia, ambra), tappeti, intarsi, fili d'oro e d'argento per broccato, fermagli di libri, ecc. Quindi verranno decorati il municipio, le case dei magnati e dei patrizi cittadini residenti in città e le istituzioni di beneficenza. Ma all'inizio i maestri dell'arte applicata lavorano principalmente per la cattedrale. I costruttori non restavano fermi in un posto, si spostavano di città in città, di campagna in campagna. Studiarono con rinomati maestri; Il sito della cattedrale in costruzione era una scuola per architetti.
Il materiale iconografico dell'epoca testimonia anche il vivo interesse dei contemporanei per il processo di costruzione del tempio: la trama della costruzione della cattedrale è spesso raffigurata in miniature di manoscritti medievali (Appendice A).
Reliquie e reliquie erano conservate nella cattedrale e i pellegrini vi accorrevano, a volte da lontano. C'era uno scambio costante tra residenti di diverse aree. Una folla eterogenea di pellegrini diretti a Canterbury per venerare le reliquie di Thomas Becket diede a Chaucer l'idea per The Canterbury Tales. La città e il tempio apprezzavano tali pellegrinaggi: portavano entrate significative.
Presso la cattedrale c'era una scuola con un corso di canto e di grammatica. In una piccola città spesso era l'unica rimasta. Quindi, a Londra nel XIV secolo. Si conoscono solo tre scuole ecclesiastiche. Le collezioni di libri ecclesiastici potevano essere piuttosto ricche, ma erano accessibili solo a una ristretta cerchia di clero e, forse, di intellettuali urbani. Le biblioteche dei municipi e delle corporazioni apparvero più tardi. Sotto il portico e d'inverno nei locali della cattedrale, scolari e studenti tenevano dibattiti. I cittadini presenti hanno apprezzato più il gesto e lo svolgimento del ragionamento che la parola: i dibattiti si sono svolti in latino. A Bologna le lezioni si sono svolte agli universitari dal pulpito esterno della Cattedrale di Santo Stefano.
Il portico della cattedrale era il luogo più frequentato della città: qui si concludevano vari affari, si assumevano lavori, qui iniziavano cerimonie nuziali, i mendicanti chiedevano l'elemosina. Avvocati londinesi sotto il portico della St. Pavel ha organizzato incontri e fornito consulenze ai clienti. Il portico è servito a lungo come palcoscenico per rappresentazioni drammatiche. Sotto il portico, e talvolta nella chiesa stessa, si tenevano le cosiddette “birre della chiesa” - un prototipo dei futuri bazar di beneficenza; si vendevano vino, vari prodotti dell'artigianato locale e agricoli. Il ricavato serviva al mantenimento del tempio, ai bisogni della parrocchia, in particolare, e al pagamento delle processioni festive e degli spettacoli teatrali. Un'usanza costantemente condannata, ma diventata sempre più frequente nel tempo. Queste feste indignarono molto i riformatori della chiesa e i fanatici della pietà in generale.
La cattedrale della città è stata a lungo luogo di riunioni comunali ed è stata utilizzata per varie esigenze pubbliche. È vero che le chiese dei monasteri e le case dei signori delle città venivano utilizzate per lo stesso scopo. Il tempio era sempre un rifugio pronto e aperto nei giorni di dolore, ansia e dubbio; poteva anche diventare un rifugio in senso letterale, garantendo l'immunità per qualche tempo. La cattedrale ha cercato di accogliere tutti, ma nei giorni particolarmente solenni c'erano troppi richiedenti. E nonostante la rigida etichetta dello stile di vita medievale, che per noi è già diventata uno stereotipo congelato, nella cattedrale c'è stata una cotta e non sempre una cotta innocua. I contemporanei hanno lasciato prove di rivolte durante le cerimonie di incoronazione nella cattedrale di Reims.
La cattedrale fu una delle realizzazioni più significative (se non la più significativa) della cultura medievale. Conteneva l'intera somma della conoscenza della sua epoca, tutte le sue idee materializzate sulla bellezza. Ha soddisfatto i bisogni dell'anima per l'alto e il bello, il non quotidiano, sia il sempliciotto che l'intellettuale. "Il simbolo dell'universo era la cattedrale", scrive uno storico moderno, "la sua struttura era concepita in tutto simile all'ordine cosmico: uno sguardo d'insieme alla sua pianta interna, alla cupola, all'altare e alle cappelle avrebbe dovuto dare un'idea completa di la struttura del mondo. Ogni dettaglio, come l'intero layout, era carico di significato simbolico. La persona che pregava nel tempio contemplava la bellezza e l’armonia della creazione divina”. Naturalmente, è impossibile ripristinare integralmente il modo in cui un normale abitante della città percepiva il servizio divino. L'esperienza dell'“azione del tempio” è stata un processo profondamente individuale e allo stesso tempo collettivo. Le norme educative e di comportamento ritualizzate si sovrapponevano alla pietà, all'impressionabilità e all'educazione dell'individuo.
4.Cittadino e tempo
Il Medioevo ereditò fin dall’antichità le tecniche per misurare il tempo. Gli strumenti per tali misurazioni erano divisi in due grandi gruppi: quelli che misuravano periodi di tempo e quelli che mostravano il tempo astronomico. I primi includono clessidra, noto fin dall'antichità, ma registrato nell'Europa occidentale solo nel 1339, e orologi da fuoco: candele o lampade a olio, la cui combustione avviene in un certo periodo di tempo. Il secondo tipo di orologi comprende solari e meccanici. Gli gnomoni solari, conosciuti già in Egitto nel V millennio a.C., si diffusero nell'Impero Romano e costituirono una decorazione quasi obbligatoria di molte ville e case. Un tipo intermedio di orologio può essere considerato una clessidra ad acqua. Anche le clessidra sono conosciute fin dal XV secolo. AVANTI CRISTO. in Egitto. Altri sono due ampolle collegate in cui viene versata l'acqua dall'una all'altra per un tempo prestabilito - tali, ad esempio, sono note in Grecia dal 450 circa. AVANTI CRISTO. "Orologio per gli altoparlanti." Un altro tipo di orologio ad acqua sono i grandi serbatoi, nei quali l'acqua scorre anche dall'uno all'altro, ma per molti giorni o, quando si collega uno dei serbatoi a un corso d'acqua naturale o artificiale, costantemente, e il tempo assoluto è determinato dall'acqua livello. Circa 150 g. AVANTI CRISTO. Ctesibio di Alessandria inventò un orologio ad acqua in cui un galleggiante in aumento faceva girare un'asta con una freccia. Questo orologio era piuttosto un calendario, calcolato per l'anno, e la lancetta segnava il giorno; Ogni ora, però, l'acqua lanciava un sassolino, che cadeva con un suono sonoro sulla lastra di metallo. Successivamente le clessidra furono modificate in modo che la lancetta indicasse l'ora anziché il giorno. (La divisione di un giorno in 24 ore e di un'ora in 60 minuti è nota in Mesopotamia nel II millennio a.C.)
Nell'alto Medioevo la misurazione precisa del tempo, soprattutto del giorno, non era comune. I primi orologi conosciuti a quel tempo - sole e acqua - furono costruiti secondo le indicazioni del famoso filosofo Boezio (c. 480-524) per ordine di Teodorico il Grande (c. 454-526; re degli Ostrogoti dal 471, re d'Italia dal 493); erano destinati come dono al re borgognone Gunvold. Dalla lettera che accompagnava questo dono era chiaro che nei regni barbarici sorti nel territorio della Gallia gli orologi erano sconosciuti (sebbene nelle ville romane della Gallia esistessero sia gnomoni che clessidra).
La bassa prevalenza degli orologi nell'alto medioevo è spiegata, in primo luogo, dall'atteggiamento (in un certo senso, indifferenza) delle persone nei confronti del tempo, in cui procedevano dalla ciclicità naturale e erano guidati da segni e fenomeni osservati nel corso dei secoli. In secondo luogo, difficoltà tecniche: sia le clessidre che gli gnomoni erano strutture immobili, voluminose e (soprattutto la prima) complesse, e le meridiane, inoltre, potevano indicare l'ora solo di giorno e con tempo sereno.
Molti pensatori medievali prestavano molta attenzione all’attenta gradazione del tempo. Ad esempio, Onorio Augustodunsky (prima metà del XII secolo) divise l'ora in 4 “punti”, 10 “minuti”, 15 “parti”, 40 “momenti”, 60 “segni” e 22560 “atomi”. Tuttavia l'unità di misura del tempo rimaneva, nella migliore delle ipotesi, un'ora, e questo, piuttosto, nell'uso liturgico, mentre nella vita quotidiana era un giorno. Gregorio di Tours (c. 538-594) nella sua opera “De cursu stellarum ratio” proponeva di calcolare il tempo in base al sorgere delle stelle e al numero dei salmi letti.
La divisione del tempo in ore uguali è stata assente per molto tempo: le ore luminose e buie del giorno erano divise ciascuna in 12 ore, quindi le ore del giorno e della notte non erano le stesse e variavano nei diversi periodi dell'anno. La divisione iniziale della giornata in 24 ore è stata effettuata in Medio Oriente, alla latitudine della quale giorno e notte sono approssimativamente uguali durante tutto l'anno, ma nelle regioni settentrionali dell'Europa la differenza era sorprendente. Uno dei primi, se non il primo, pensatori ad esprimere il desiderio di pareggiare gli orologi fu l'anglosassone Beda il Venerabile (c. 673-731), come risulta dal suo trattato De ratione computi. Lui o la sua cerchia appartiene al primo calendario, che indica la distribuzione del tempo di luce e di oscurità alla latitudine della parte centrale delle Isole britanniche: “Dicembre - ore notturne XVIII, ore diurne - VI; Marzo - ore notturne XII, ore diurne - XII; Giugno - ore notturne VI; diurno – XVIII”, ecc. Dopo l'invenzione orologio meccanico e fino all'inizio del XVII secolo. Sono stati utilizzati azionamenti regolabili molto complessi, che hanno permesso di dividere la giornata in periodi di tempo disuguali - ore del giorno e della notte, quindi l'idea di un'ora come unità di tempo costante si è diffusa piuttosto lentamente e inizialmente solo in chiesa uso, laddove fosse causato da necessità liturgica. La costanza dell'ora cominciò ad essere mantenuta particolarmente attivamente nel X secolo, durante il processo della riforma di Cluny, al fine di unificare il rituale ecclesiastico, che prevedeva, tra l'altro, la simultaneità delle funzioni religiose (non ne conoscevano la fuso orario quindi).
Ricercatori del 19° secolo L'invenzione degli orologi meccanici fu attribuita al famoso scienziato Herbert di Aurillac (c. 940-1003), che divenne orologiaio nel 999. Papa sotto il nome di Silvestro II. In effetti, migliorò solo (c. 983) la clessidra, e ora il suo asse ruotava sotto l'influenza dell'acqua che cadeva; ciò ha permesso di sostituire successivamente la forza dell'acqua con il peso dei pesi, cioè. facilitato la creazione di orologi meccanici.
Le ragioni della comparsa di quest'ultimo erano più socio-psicologiche che tecniche. La misurazione accurata del tempo veniva effettuata solo all'interno dello spazio della chiesa, mentre all'esterno il tempo non veniva misurato con la stessa precisione.
6. Delitto del Medioevo.
Fino all’inizio del XX secolo, gli storici dipingevano immagini romantiche di uguaglianza e unità comunitaria dei cittadini medievali, presumibilmente uniti come fronte unito contro i loro signori secolari e spirituali.
Lo studio della povertà urbana è ostacolato dallo stato delle fonti, soprattutto per i primi secoli di storia urbana. Le fonti diventano più eloquenti solo avvicinandosi al tardo Medioevo. Ma sarebbe un errore concludere da ciò che la povertà sia un fenomeno eccezionale di questi secoli.
Di seguito parleremo di rappresentanti specifici del mondo sotterraneo della Francia medievale e della Borgogna: ladri professionisti.
I problemi della criminalità urbana occupavano costantemente le menti dei funzionari. Potenziali criminali erano considerati coloro che si rifiutavano di lavorare e conducevano uno stile di vita dissoluto, visitando taverne e bordelli. Queste persone pigre danno il “cattivo esempio” a chi li circonda, trascorrendo tutto il loro tempo giocando d’azzardo e bevendo con il pretesto di ciò salario non abbastanza alto. In secondo luogo, persone che non avevano alcuna professione dignitosa.
La città era il luogo ideale per la creazione e l'esistenza di una banda. Potresti incontrare chiunque per le sue strade. Inoltre, il furto non è considerato solo una professione, in esso, come in ogni mestiere, esiste una certa specializzazione.
Già nel XIII secolo. A Parigi c'era una banda di “sporchi babbuini” (“livilains Baubuins”) che attiravano i sempliciotti nella cattedrale di Notre Dame e, mentre guardavano le sculture di Pipino e Carlo Magno, si tagliavano i portafogli dalla cintura.
Esistono i seguenti tipi di maestri, specialità dei ladri:
- "ladro" - qualcuno che sa come aprire le serrature
“collezionista” - colui che taglia i portafogli
"beffardo" è un ladro che attira un sempliciotto, gioca
“mittente” è l'assassino
“lanciatore” - qualcuno che vende lingotti d'oro contraffatti.
Nulla, infatti, potrebbe davvero escluderli dalla vita della società. I criminali professionisti vivevano in “simbiosi” con la popolazione cittadina; potevano anche collaborare con le autorità, soprattutto con la nobiltà.
7. Il ruolo della Chiesa nell'Alto Medioevo
La caratteristica più importante della cultura medievale è il ruolo speciale della dottrina cristiana e della chiesa cristiana. Nelle condizioni del declino generale della cultura immediatamente dopo il crollo dell'Impero Romano, solo la Chiesa rimase per molti secoli l'unica istituzione sociale comune a tutti i paesi, tribù e stati dell'Europa occidentale. La Chiesa non era solo l'istituzione politica dominante, ma esercitava anche un'influenza dominante direttamente sulla coscienza della popolazione. In condizioni di vita difficile e misera, sullo sfondo di una conoscenza estremamente limitata e inaffidabile del mondo che ci circonda, la chiesa ha offerto alle persone un sistema coerente di conoscenza del mondo, della sua struttura e delle forze che operano in esso. Questa immagine del mondo determinava interamente la mentalità dei credenti abitanti dei villaggi e delle città e si basava su immagini e interpretazioni della Bibbia.
L'intera vita culturale della società europea di questo periodo fu in gran parte determinata dal cristianesimo.
La popolazione era tradizionalmente dedita ai culti pagani e alle prediche e le descrizioni della vita dei santi non bastavano a convertirla alla vera fede. Le persone furono convertite a una nuova religione con l'aiuto del potere statale. Tuttavia, molto tempo dopo il riconoscimento ufficiale di un'unica religione, il clero dovette combattere i resti persistenti del paganesimo tra i contadini.
La Chiesa distrusse templi e idoli, proibì di adorare gli dei, fare sacrifici e organizzare feste e rituali pagani. Furono minacciate severe punizioni per coloro che si dedicavano alla predizione del futuro, alla divinazione, agli incantesimi o semplicemente credevano in essi.
La formazione del processo di cristianizzazione è stata una delle fonti di scontri acuti, perché La gente spesso associava i concetti di libertà popolare all'antica fede, mentre il legame della Chiesa cristiana con il potere statale e l'oppressione appariva abbastanza chiaramente.
Nella mente delle masse della popolazione rurale, indipendentemente dalla fede in certi dei, rimanevano atteggiamenti di comportamento in cui le persone si sentivano direttamente incluse nel ciclo dei fenomeni naturali.
Questa costante influenza della natura sull'uomo e la fede nell'influenza dell'uomo sul corso dei fenomeni naturali con l'aiuto di un intero sistema di mezzi soprannaturali era una manifestazione della coscienza magica della comunità medievale, una caratteristica importante della sua visione del mondo.
Nella mente degli europei medievali, il mondo era visto come una sorta di arena di confronto tra le forze del paradiso e dell'inferno, del bene e del male. Allo stesso tempo, la coscienza delle persone era profondamente magica, tutti erano assolutamente fiduciosi nella possibilità dei miracoli e percepivano tutto ciò che la Bibbia riportava in senso letterale.
In termini più generali, le persone vedevano il mondo secondo una certa scala gerarchica, o meglio, come un diagramma simmetrico, che ricorda due piramidi piegate alla base. La parte superiore di uno di essi è Dio. Di seguito sono riportati i livelli dei personaggi sacri: apostoli, arcangeli, angeli, ecc. A un certo livello, in questa gerarchia vengono incluse le persone: prima il papa e i cardinali, poi i chierici di livello inferiore, poi i laici, a cominciare dalle autorità secolari. Poi, più lontani da Dio e più vicini alla terra, c'erano gli animali e le piante, poi la terra stessa, già completamente inanimata. E poi c'era una sorta di riflesso speculare della gerarchia superiore, terrena e celeste, ma in una dimensione diversa, come con un segno "meno", secondo la crescita del male e la vicinanza a Satana, che era l'incarnazione del Male. .
Pertanto, i segni della cultura altomedievale possono essere considerati l'adesione alla tradizione, il conservatorismo di tutta la vita sociale, il predominio degli stereotipi in creatività artistica, la persistenza del pensiero magico, imposto alla chiesa.
7.1 Il ruolo della Chiesa nell'educazione
Nei secoli V-IX tutte le scuole nei paesi europei erano nelle mani della chiesa. Ha redatto un curriculum e selezionato gli studenti. La Chiesa cristiana conservò e utilizzò elementi della cultura secolare rimasti dall'antico sistema educativo: nelle scuole ecclesiastiche insegnavano discipline ereditate dall'antichità: grammatica, retorica, dialettica con elementi di logica, aritmetica, geometria, astronomia e musica.
La scienza universitaria medievale era chiamata scolastica. L'influenza della chiesa sulle università medievali fu enorme. Le donne nel Medioevo, di regola, salvo rarissime eccezioni, non ricevevano un'istruzione. Alcune nobili dame potevano permettersi un'istruzione, ma di solito le donne venivano tenute in disparte, e anche se gli uomini nobili non ricevevano un'istruzione, poiché erano interessati agli affari militari e non ai libri, allora non venivano spesi molti sforzi e soldi per le donne. in questo senso..
Bisanzio durante l'alto medioevo fu caratterizzato dal rafforzamento della posizione della Chiesa cristiana nel campo dell'educazione, che si espresse nella persecuzione della filosofia antica. La filosofia antica fu sostituita dalla teologia. Un rappresentante di spicco della cultura bizantina di questo tempo fu il patriarca Fozio, il compilatore di "Mariobiblion" - una raccolta di recensioni di 280 opere di autori principalmente antichi, autori di opere teologiche.
8.Conclusione
Rispondendo alle domande che ho posto all'inizio, possiamo dire che il Medioevo, per quanto barbaro fosse, coltivava il senso del dovere, anche se solo per orgoglio. Per quanto limitata fosse la conoscenza di quel tempo, almeno insegnava prima a pensare e solo poi ad agire; e poi non c'era l'ulcera della società moderna: l'autocompiacimento. E il Medioevo è considerato ingenuo.
Indubbiamente, la cattedrale e la chiesa hanno svolto un ruolo importante nel determinare la mentalità dei residenti.
Insieme alla povertà di quel tempo e ai problemi della criminalità, furono organizzati lussuosi viaggi di nobili e gare cavalleresche.
Il coraggio e la destrezza dei cavalieri, la diversità delle forme di tutto ciò che toccava la mente e i sentimenti, la vita quotidiana eccitava e accendeva la passione, che si manifestava o in esplosioni inaspettate di cruda sfrenatezza e brutale crudeltà, o in esplosioni di reattività spirituale, in l'atmosfera mutevole di cui scorreva la vita della città medievale. In una parola, la vita conservava il sapore di una fiaba.
Appendice A
Bibliografia:
1. AA. Svanidze "Città in civiltà medievale Europa occidentale" vol. 3, vol. 4 M. "Scienza", 2000
2. L.M. Bragin “Cultura rinascimentale e vita religiosa dell'epoca” M. “Scienza”, 1997
3. A.Ya Gurevich "Problemi della cultura popolare medievale" M., 1981
4. J. Huizinga “Autunno del Medioevo”